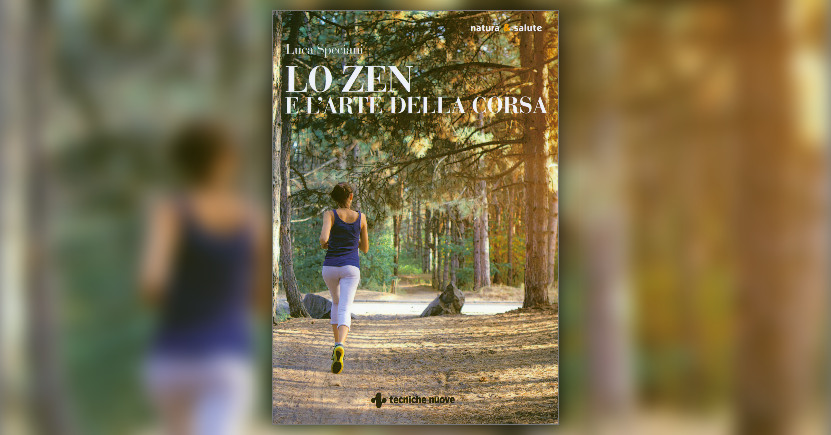Uno dei, una delle
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto da "Lo Zen e l'arte della Corsa" di Luca Speciani per scoprire il legame tra zen e corsa
Quando sentiamo parlare di buddhismo o di induismo, condizionati dal nostro retroterra culturale, siamo soliti pensare a qualche religione esotica, magari dedita al culto di idoli o ai sacrifici umani, o a qualche strana superstizione come il rifiuto delle carni o l'adorazione di statue e di animali. Così mettiamo voodoo, totem indiani, fachiri ed eremiti nello stesso pentolone delle credenze ingenue e infantili. Poi, tranquilli, andiamo a leggerci l'oroscopo o a implorare qualche santo che risolva i nostri problemi.
Potrebbe anche essere ora di far suonare la sveglia.
In anni recenti il buddhismo ha conquistato un certo numero di nuovi adepti, grazie alla involontaria sponsorizzazione di alcuni vip, tra cui Roberto Baggio, Marco Columbro, Richard Gere, Tiger Woods, Sabina Guzzanti. Orlando Bloom, Léonard Cohen, Penelope Cruz che hanno creato intorno all'argomento un'atmosfera di curiosità e mistero. Ma in che cosa veramente consista il buddhismo, e fino a dove arrivi lo zen, pochi lo sanno, e ancora meno persone lo vivono.
Stai leggendo un estratto da:
Non è facile né immediato capire di che cosa tratti il buddhismo. Figuriamoci allora capire in che modo questo possa influenzare il nostro modo di correre. Ma abbiate fiducia, perché le due cose sono, per noi atleti, strettamente collegate. E mi perdoneranno filosofi e teologi per le necessarie semplificazioni.
È curiosa inoltre l'immagine che molti hanno dell'uomo Buddha come di un uomo grassissimo, giustificata dall'esistenza di alcune statue che così lo raffigurano. Tale immagine è in totale antitesi con quella riportata (per esempio) nel film "Piccolo Buddha" con il magrissimo Keanu Reeves. O con il fatto che esistano ben pochi monaci buddhisti grassi.
Di certo l'uomo Buddha, privo di attaccamenti, ben difficilmente avrebbe potuto soggiacere a quello, elementare, del cibo. Diciamo allora, per chiarire, che se in alcuni periodi storici la venerazione per il santo si era espressa in immagini con ciò che allora era visto come bellezza e abbondanza, ciò non vuol dire che tale immagine corrispondesse al vero. Pensare al Buddha come a un uomo grasso, pigro e indolente rientra nel novero delle "spiegazioni di comodo" che ci portano superficialmente a pensare che la nostra religione sia l'unica "giusta".
Liberiamoci, una volta per tutte, di qualsiasi immagine del Buddha, bella o brutta, grassa o magra, e poniamoci, finalmente, in ascolto.
Se per un cattolico è facile capire la religione musulmana o quella ebraica, entrambe monoteiste e con moltissimi punti di contatto (Dio o Allah, profeti, scritture, santi, peccati, paradisi, penitenze), meno facile può essere capire la figura di Buddha, che non dice di essere Dio, né figlio o messaggero di Dio, ma solo uomo. Forse più vicino alla figura di un Gandhi, di un Socrate, di un S. Francesco o di una Madre Teresa.
Perché mai, allora, dovremmo edificare un sistema di pensiero su qualcuno che per sua stessa definizione è solo un uomo? Perché le cose che ha detto e fatto Buddha nella sua vita sono talmente particolari che può valere la pena di costruirci sopra un pezzo del proprio percorso. Se poi questa sia religione o filosofia, o altro, non è così importante. C'è tanto da imparare, tanto da applicare, e tanta strada per capire come stare bene, con sé e con gli altri.
Buddha (al secolo Siddharta Gotama, o Sakyamuni) visse in India nel sesto secolo a.C. e, figlio di un re, abbandonò la vita di corte per dedicarsi alla comprensione della causa della sofferenza nel mondo. Passò attraverso diverse esperienze: la povertà, l'ascesi, finché ebbe l'illuminazione (Buddha significa "il risvegliato") e iniziò a predicare ciò che aveva interiormente compreso.
Proverò a sviluppare una succinta sintesi del tutto personale, che non ha alcuna pretesa di completezza, sul pensiero del Buddha.
Prima di tutto Buddha evidenzia il fatto che la sofferenza è legata al desiderio e all'attaccamento. Attaccamento alle cose, attaccamento alle persone, attaccamento agli obiettivi. Il suo consiglio è quello di "lasciare andare" (noi diremmo "di volare alto"), ovvero di accettare la vita e le cose, così come sono: senza forzarle, senza volere imporre la nostra visione. Predica inoltre il rispetto di ogni forma vivente e non vivente. Suggerisce di seguire alcuni precetti, che qui non è il caso di approfondire (ma che non prevedono né il celibato né l'astinenza), e che comunque rappresentano un mezzo e non un fine.
Predica la compassione, che deve permeare ogni nostro gesto. Invita a fare conto SOLO su se stessi per affrontare i propri problemi e a non richiedere interventi esterni, neanche con la preghiera. Per il Buddha tutto scorre, tutto è impermanente, prima o poi svanisce o cambia: dalla più piccola inquietudine alla nostra stessa vita.
Con l'attaccamento a ciò che "non è reale" noi otteniamo una visione falsata del mondo che ci circonda. Se invece svuotiamo il nostro sé dalle nebbie dell'egoismo, dalla schiavitù del pensiero, dalle nostre continue aspettative, allora possiamo "vedere".
La visione del mondo "così com'è" è possibile attraverso la meditazione, che non è un'attività di pensiero, ma di "non pensiero". Essa porta, attraverso una sempre maggiore consapevolezza di ciò che siamo e facciamo, all'illuminazione, cioè alla chiara visione. E attraverso la chiara visione, noi percepiamo la realtà non più come dualità bene/male, bello/brutto, vita/ morte, spirito/materia, ma come un tutt'uno di cui anche noi siamo parte.
Tutto questo lo predica con il "sorriso del Buddha". Calmo, gentile, pacificato, risvegliato, privo di attaccamenti, pieno di compassione e amore. Dimostrazione vivente dei frutti dell'illuminazione: con serenità, amore, tolleranza, rispetto, consapevolezza, gioia di vivere.
Tutto qui, direte? Tutto qui.
Si tratta però di un "tutto qui" talmente rivoluzionario da procurargli un numero enorme di seguaci e un seguito grandissimo nei secoli successivi. Dapprima in India, e successivamente in Cina e Giappone, dove nasce, all'incirca nel 600 d.C, lo zen.
In Cina, dove imperano Taoismo e Confucianesimo (due religioni molto pratiche e legate al quotidiano), il buddhismo si svuota della maggior parte degli aspetti rituali e speculativi (peraltro già ridotti all'osso) e nasce lo zen, come corrente di pensiero ancora più rivolta all'istintività e alla spontaneità dei gesti.
Lo zen, che non contraddice in alcun modo le basi teoriche del buddhismo, si pone però fin da subito in una posizione critica, rifiutando a priori il valore delle scritture, la rigidità dei precetti, le speculazioni mentali e qualunque simbolo (basti pensare a quel detto zen che recita "Se vedi il Buddha uccidilo", cioè non attaccarti a NESSUN simbolo). Dà quindi massimo valore all'esperienza e all'istintività, sottolineando con forza il valore delle sedute di meditazione come mezzo per evolversi e raggiungere l'illuminazione.
Pratica quotidiana, quindi, in contrasto con le letture, le preghiere, i riti, lo studio teorico di testi e problemi teologici. È proprio questo rifiuto delle gerarchie, dell'autorità, del dogmatismo e delle strutture che fa dello zen la "pecora nera" del buddhismo. Una "eresia" che ha potuto sopravvivere all'ortodossia solo grazie alla grandissima tolleranza orientale. In occidente (dove si sono eretti roghi per coloro che mettevano in dubbio qualche dogma) probabilmente sarebbe durata poche settimane.
L'arte zen, per esempio, sia essa pittura, scultura o poesia, è del tutto immediata e viene realizzata attraverso tratti istintivi e spontanei, così come vengono, per cogliere la bellezza o la poesia di un istante.
Questi concetti che leggete, ci crediate o no, oltre che nel contenuto, sono stati scritti anche in "modo" zen, cioè istintivamente, seguendo l'ispirazione e (con i necessari ritocchi) trasformandola in parole scritte. Si perderà forse un po' di organicità dell'insieme, ma la freschezza del contenuto emergerà (se c'è) prepotente. Nella speranza che il messaggio che voglio trasmettere venga colto a livello istintivo, più che razionale.
L'istintività nell'arte zen è semplicità e immediatezza. Un uccello in volo per lo zen è un uccello in volo. Cercare di riprodurlo, impagliarlo, descriverlo o anche solo pensarlo, ne fa una cosa morta. L'unico modo per percepirlo è coglierlo nell'istante. E per cogliere l'istante sono necessarie consapevolezza e chiara visione. Non interpretazioni teologiche, non gerarchie ecclesiastiche, non lunghe descrizioni, non misteri della fede. Mordere la mela, piuttosto. E sentirne il sapore.
Una bellissima poesia di Ikkyu ribadisce il concetto: "Quel Buddha di pietra merita tutto il guano di uccello che gli cade sopra. Agito le mie scarne braccia come un alto fiore nel vento."
Non ha alcuna importanza il simbolo. Quello che è veramente reale è la vita, le mie braccia scarne in movimento. Che nella loro semplicità hanno la bellezza di un fiore sospinto dal vento. Infinitamente più vero di qualunque immagine sacra o profana.
Nel giro di alcune centinaia di anni lo zen si diffonde in Cina e in Giappone (dove diventa la pratica buddhista prevalente), mentre in India e in Tibet il buddhismo mantiene caratteri più ortodossi.
Oggi, a causa della silenziosa invasione cinese del Tibet, il buddhismo in Cina è perseguitato e affiancato da un culto di facciata, accettato dal governo. In compenso scuole zen giapponesi si sono sviluppate negli Stati Uniti fin dai primi anni '60, trovando importanti testimonial (Alan Watts, Jack Kerouac, Allen Ginsberg), e oggi non c'è grande città europea che non abbia un tempio zen più o meno seguito.
In ogni caso, a causa della totale non-violenza, e della assenza di qualsiasi forzatura nel fare proseliti, la presenza buddhista (e ancor più quella zen) è sempre discreta, poco chiassosa, e rispettosa delle altrui convinzioni.
Un punto che ritengo di estrema importanza da affrontare qui (e che trovo perfettamente naturale nella mentalità orientale) è infatti che nessun praticante zen si sognerebbe mai di imporre le proprie idee e le proprie convinzioni a qualcun altro con la forza (plagio, coercizione, imposizione). A differenza di molte altre religioni, che nei secoli si sono macchiate dei più gravi crimini, pensando di fare cosa gradita ai loro dei.
Non solo, ma lo zen non si pone nemmeno l'obiettivo specifico di fare adepti o di allargare il numero dei seguaci. Se questo avviene, è perché la compassione dei singoli praticanti porta a diffondere questi concetti che, prima di qualunque altra cosa, ci aiutano a stare bene con noi stessi e a trovare una maggiore armonia interiore.
L'intima convinzione di chi pratica (poiché professa la tolleranza verso le altre opinioni e il non attaccamento alla propria) è che lo zen non rappresenti IL percorso, ma UNO DEI possibili percorsi, UNA DELLE possibili strade verso se stessi e verso la comprensione della realtà. Naturalmente, nella mia convinzione, un percorso bellissimo e una strada entusiasmante.
Mi piacerebbe che tutti i consigli e le spiegazioni (soprattutto quelli legati alla corsa) che discuteremo in queste pagine (anche se esposti con passione) fossero interpretati in questa chiave.
Ma quali sono i legami tra zen e attività sportiva, e in particolare tra zen e corsa? Sono moltissimi, e molto più stretti di quanto si possa pensare, sia per l'ultramaratoneta sia per colui che si accosta per la prima volta a qualche passo di corsa.
Vale sicuramente la pena di capirli uno per uno.