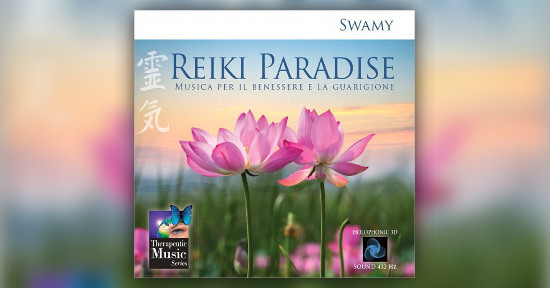Guarire con una fiaba
Pubblicato
2 anni fa
Usare l'immaginario per curarsi
Vediamo insieme alcuni concetti fondamentali relativi alla struttura della fiaba, al simbolismo delle figure che ricorrono più frequentemente, all'applicabilità del metodo della fiabazione nella terapia dei disturbi psicosomatici e alla sua possibilità di essere usato personalmente come strumento di aiuto alla guarigione.

Fiabazione
La fiabazione è utilissima come strumento conoscitivo e permette di comprendere certe dinamiche profonde con rapidità e ricchezza di elementi.
Il solo fatto di rappresentare simbolicamente con una fiaba la propria situazione ha un immediato effetto terapeutico, perché avvicina dei processi profondi in corso, spesso inconsci e a volte anche corporei, alla coscienza e ne facilita cosi la comprensione e la gestione.
Oltretutto l'immaginario costituisce un meraviglioso campo di esperimento, limitato e innocuo, delle possibili soluzioni a problemi.

A livello immaginario si possono inventare, provare e riprovare, infiniti percorsi, seguendoli fino alle loro estreme conseguenze alla ricerca delle modalità più appropriate di gestione di una difficoltà.
La fiaba per tutti
L'origine delle fiabe si perde nella notte dei tempi.
Prima dell'introduzione della scrittura l'intero patrimonio culturale di un popolo si perpetuava per trasmissione orale.
I vecchi del villaggio "raccontavano" ai giovani tutta la loro esperienza, e tutta l'esperienza dei loro padri e dei loro nonni. Trasmettevano così non solo il bagaglio di tecniche fino ad allora acquisito, ma anche quel complesso culturale fatto di credenze religiose, di pratiche rituali, di interpretazioni del mondo, che era stato lentamente elaborato nei secoli precedenti.

Nella trasmissione orale primitiva il mito la leggenda e la fiaba trovavano posto insieme, all'interno della trasmissione del patrimonio culturale.
Era fiaba per tutti dunque, fiaba per adulti, per vecchi e per bambini: fiaba per l'intero popolo.
La trasmissione non avveniva infatti di norma in forma individuale o casuale: l'intero villaggio si raccoglieva attorno ai Grandi Vecchi, che davano inizio ad alle narrazioni. E questo momento rituale costituiva il cuore della vita intellettuale e spirituale dell'intera tribù.
Le trascrizioni, già di molto successive, ci riportano parte di questo enorme patrimonio di miti, di fiabe e di leggende elaborate in tutti i luoghi del mondo.
Gli scritti sono stati poi raccolti, persi e ritrovati nel corso dei secoli, tradotti e ritradotti, rielaborati nel passaggio tra lingue e culture diverse. Hanno subito influenze, commistioni e divulgazioni, per cui oggi la distinzione precisa tra miti, leggende e fiabe è oggetto di studi specifici.
È molto importante sottolineare l'universalità dei temi principali ricorrenti nei miti, nelle leggende, nelle parabole e nelle fiabe, che s'intrecciano con la storia degli albori delle religioni, come già da tempo è stato ben rilevato da molto studiosi: si vedano per esempio i lavori di Karoly Kerenyi, James G. Frazer, Mircea Eliade, Claude Levi Strauss e di moltissimi altri.

È proprio sull'universalità dei simboli ricorrenti nei sogni dei suoi pazienti, quanto nei miti e nei riti dell'umanità intera, che Carl Gustav Jung ha strutturato la teoria degli "archetipi" e dell'"inconscio collettivo."
Marie-Louise von Franz apre il suo libro Le fiabe interpretate scrivendo: "Le fiabe sono l'espressione più pura e semplice dei processi psichici dell'inconscio collettivo" e più oltre: "Il linguaggio della fiaba sembra essere il linguaggio internazionale di tutta l'umanità, di tutte le età e di tutte le razze e le civiltà".
La fiaba di Cenerentola, per esempio, con il suo tema della scarpina perduta che permette di ritrovare l'amata, comparve secondo Bruno Bettelheim per la prima volta in forma scritta in Cina, durante il nono secolo a.C., e aveva già una lunga storia alle spalle.
In una raccolta di favole e racconti del'Egitto faraonico, a cura di Aldo Troisi, la fiaba La fortuna di Rodopi è considerata la più antica versione conosciuta della fiaba di Cenerentola.

Antica Cina... Egitto faraonico...secoli a.C. Le fiabe sono già state studiate e a fondo, da molti punti di vista: storico, antropologico, letterario, psicoanalitico, sociologico, linguistico, artistico.
Alcuni vantaggi della fiabazione
Utilizzando questo metodo di fiabazione si possono anche ricavare altri elementi preziosi di informazione su se stessi, riguardanti la fase di vita che si sta attraversando e le difficoltà e le opportunità a essa connesse:
- se la fiaba inventata riguarda un/una protagonista che deve procurarsi innanzitutto i mezzi di sopravvivenza, come accade per esempio nelle fiabe di bambini abbandonati nel bosco, il compito, per così dire, di quella fase della propria vita riguarda la strutturazione di solide basi dell'Io, della propria autonomia personale e della fiducia in se stessi;
- nel caso la fiaba abbia come scopo il convolare a felici nozze, riguarda in genere il tema dell'integrazione delle proprie parti femminili e maschili, il risolvere delle dicotomie e dei conflitti interiori che si riflettono poi anche nei rapporti con gli altri;
- quando la fiaba indica specificamente come compito la sola acquisizione di una qualche capacità superiore o il superamento di qualche prova in sé, si riferisce di solito a un cammino di crescita interiore in senso stretto.

La fiaba è come un ciclo vitale: finito uno ne comincia un altro, finito l'inverno ritorna la primavera, ma finita l'estate ritornerà l'inverno...
"Vissero felici e contenti" è il lieto fine di un piccolo ciclo vitale, ma poi: "Dopo un po' che stavano vivendo felici e contenti, successe che..." e un'altra fiaba comincia, con tutte le sue peripezie e le sue avventure.
È il ciclo della vita stessa che ci sorride.

I personaggi delle fiabe
La Principesssa
La principessa è generalmente il personaggio femminile meglio delineato dalla fiaba.
Il fatto che si tratti di una principessa nelle fiabe sottolinea simbolicamente il grande valore che si intende attribuire a questa figura non c'entrano assolutamente le connotazioni socio - economiche .
Nei miti e nelle leggende è la figlia del re, colei che deve essere sacrificata al mostro per placarne la ferocia a vantaggio di tutto il popolo; è la figlia del re che innamoratasi dell'eroe ne rende possibile la fuga; è la figlia del re che bagnandosi nel fiume trova in una cesta il mitico neonato in balia delle acque.
Nelle fiabe quando la protagonista è femminile se non nasce principessa tende a diventarlo alla fine del racconto.
Anche questa è un'indicazione simbolica del valore del percorso compiuto, non certo dell'acquisizione di uno status sociale.
Osserviamo più in generale quali sono i percorsi classici compiuti dalle protagoniste femminili nelle fiabe.
Se si tratta di bambine, che siano figlie di re o di poverissimi contadini, il racconto si sviluppa da una situazione di partenza in cui la protagonista viene abbandonata, rapita o venduta, oppure è angariata dalla matrigna e dalla dalle sorellastre o si perde nel bosco.
La narrazione procede attraverso mille peripezie verso l'obiettivo di una casa sicura dove poter crescere finché è una bambina (Cappuccetto Rosso o Gretel), o delle nozze con il principe se è più grande (Cenerentola, Biancaneve, ecc.).

Vediamo qui toccati due grandi temi: quello del raggiungimento delle condizioni indispensabili alla crescita, a partire da una situazione iniziale sfavorevole, e quello del completamento del proprio percorso di sviluppo, superando gli ostacoli che ne minacciano l'arresto, fino al raggiungimento di un'integrazione degli aspetti femminili e maschili rappresentata simbolicamente dalle "nozze".
Ogni bambina ha delle difficoltà a mantenere a livello di coscienza alcune tendenze che la qualificherebbero come "cattiva" agli occhi dell'ambiente.
Non può autopercepirsi come malvagia senza esporsi a un'ansia intollerabile. Si sdoppia allora lei stessa nelle fiabe, in una "bimba buona" e "bimba cattiva": Cenerentola e le sorellastre, ombre le une delle altre, facce scotomizzate dell'unità del soggetto reale.
La competitività femminile si trasforma negli anni e si rivolge verso le rivali nella ricerca del partner.
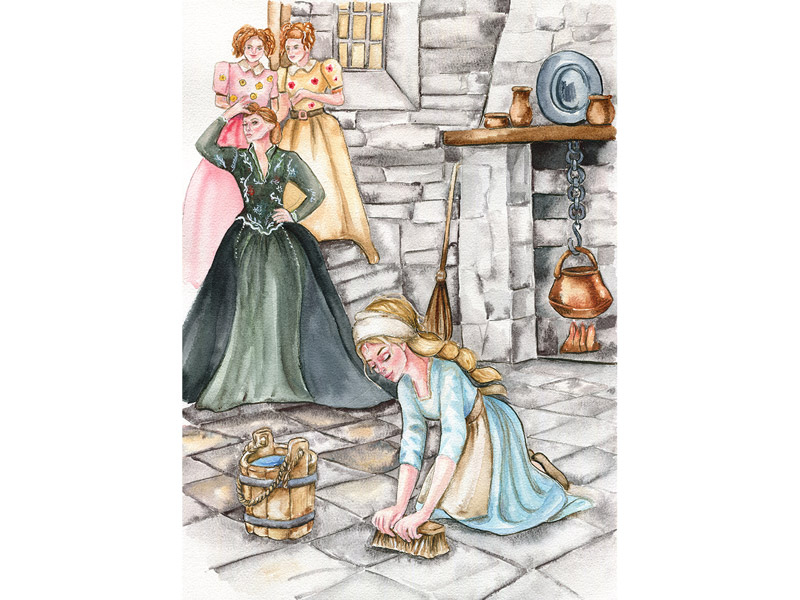
Nelle fiabe è spesso la "sorellastra", aiutata dalla matrigna cattiva, quella che tenta di sostituirsi alla protagonista al momento delle nozze con il principe.
Nel mondo delle fiabe i personaggi "cattivi" vengono ben delineati: nel lieto fine non esercitano la funzione dominante, ma non spariscono da soli o per caso, e nell'insieme della fiaba non sono mai inesistenti.
Il male è il dolore non sono negati, anzi, i cattivi e le sofferenze svolgono una parte ineliminabile nell'intreccio del racconto: se non ci fossero non ci sarebbe neanche la fiaba.
La fiaba è tutto il percorso immaginario con cui il protagonista li affronta e li supera. La parte negativa dell'individuo è ben rappresentata con tutte le sue caratteristiche e i suoi sentimenti, non dall'eroe o dall'eroina ma dal suo antagonista.

Il processo che la fiaba prospetta è un processo di superamento, non di censura o di negazione delle parti ombra. L'unità complessa e contraddittoria dell'individuo reale, con i suoi lati luminosi e con quelli oscuri, con le sue qualità le sue debolezze, è rappresentata dall'unità di tutti i personaggi della fiaba, non dalla sola figura della protagonista.
La fiaba nel suo complesso descrive un equilibrio oscillante, il movimento, che conferisce al protagonista eroico la funzione trainante ma che include per definizione "il male come elemento costituente".
Inventare una fiaba può essere utile a tutti per sviluppare la creatività e per approfondire l'autoconoscenza, serve per mantenersi più in contatto con se stessi per mettere a fuoco i propri bisogni i desideri e le potenzialità.
Si può per esempio inventare una fiaba ogni tanto, senza uno scopo preciso e questo è il metodo migliore. La fiabazione è uno dei tanti modi per esprimere se stessi e per mantenere vive le proprie parti più creative: può scaturirne una poesia, una musica, un disegno.
Mentre stiamo inventando una fiaba siamo completamente immersi in un processo creativo e lo lasciamo scorrere spontaneamente. Per questo inventare una fiaba fa bene:
È un lasciarsi andare al fiume della vita e fidarsi del suo fluire