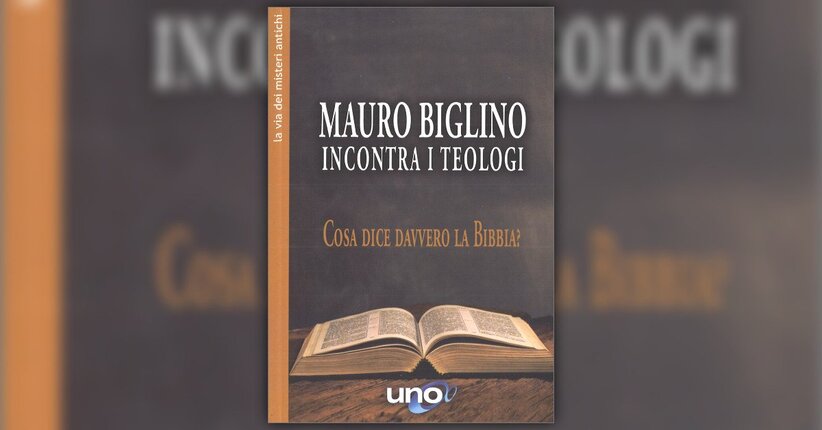Il peccato originale
Leggi un estratto da "Mauro Biglino Incontra i Teologi" e scopri come le diverse confessioni vedono il Peccato Originale
Sabrina Pieragostini: «Stiamo per concludere questa prima parte di domande. Ora vi chiedo: come sappiamo che è davvero esistito il peccato originale e che le sue conseguenze hanno coinvolto l'umanità intera?».
Mauro Biglino
«Dunque, il mio pensiero personale leggendo la Bibbia, ma leggendo anche quella delle traduzioni tradizionali, è che la Bibbia non parli di un peccato originale. Nel senso che non trovo nell'Antico Testamento una colpa che sia stata punita, e punita in modo tale da determinare una macchia all'interno dell'umanità. E, giustamente, dicevano prima gli ultimi due relatori, dottor Garrone e Don Segatti, ci sono delle traduzioni e ci sono delle Bibbie che sono oneste perché mettono delle note. Per esempio torno alla Bibbia di Gerusalemme che, parlando proprio della cacciata di Adamo ed Eva dal cosiddetto paradiso terrestre, dice testualmente: "Non si tratta di una punizione per una colpa già commessa ma si tratta di una decisione preventiva" (sto proprio citando a memoria, eh, poi se volete lo leggiamo). "E", dice, "quindi non va cercato qui ciò che vi è stato letto successivamente".
E continua: "In particolare la lettura di Paolo - Lettera ai Romani e Lettere ai Corinzi - è non va cercato qui ciò che poi è stato elaborato dalla teologia successiva". Cioè, il concetto del peccate originale non va cercato lì, nel senso che è un prodotto di un'elaborazione successiva. Cosi almeno è scritto in quella nota, e io per altro, concordo assolutamente.
Pertanto il problema che si pone è, ovviamente dal mio punto di vista, chiaramente, se nella Bibbia, come a me appare, non si parla del Dio Padre Onnisciente, Onnipotente, eccetera, e se nella Bibbia non c'è un peccate originale, la domanda è: se manca il mandante e manca il movente, chi è che ha mandato Gesù Cristo, e per che cosa è stato mandato?
Quindi questa è la domanda che mi faccio io da ciò che mi pare di ricavare, ovviamente, dall'Antico Testamento. Questo c ciò che io leggo, che il peccato originale non c'è.
Tenendo presente che leggendo sempre la Bibbia mi pare di capire che, allegoria o verità che sia, Adamo ed Eva non risulterebbero essere i progenitori dell'intera umanità, ma i capostipiti di un gruppo, di una famiglia, di un clan specifico, dico: qualora ci fosse, ma ripeto secondo me non c'è, semmai il peccato l'avrebbe commesso quel clan, non l'umanità intera.
Ma insomma, questa sarebbe un'altra discussione in più e non la voglio introdurre, ci mancherebbe. Diciamo che secondo me il peccato originale non c'è, con tutto ciò che questo comporta in termini di conseguenze neotestamentarie».
Ariel Di Porto
«Io con questa domanda in realtà inizio gradualmente a eclissarmi per ovvi motivi insomma, perché entrando in ambito di Nuovo Testamento chiaramente ho un po' di difficoltà parlarne perché non voglio offendere le sensibilità di nessuno».
Mons. Avondios: «Assolutamente no».
Ariel Di Porto: «No no... ma comunque non ho neanche le competenze. Per cui volendo dare un parere tecnico ritengo di dover sapere esattamente di cosa sto parlando, cosa che in questo caso non sarebbe vera.
Quello di cui parliamo è un testo che appartiene pienamente alla tradizione dell'Antico Testamento, per cui ne posso parlare e ne parlo volentieri.
Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica, il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica.
Ciò che possiamo ricavare è quello che leggiamo all'atto pratico all'interno del testo. Ciò vale a dire le conseguenze che questo peccato ha portato. Cioè per cui da una parte la mortalità dell'uomo, c'è questo elemento all'interno del testo, la cacciata dall'Eden, e tutte queste cose comportano un cambiamento di condizione per quanto riguarda l'uomo.
Uscire dall'Eden vuol dire in qualche modo uscire da una certa condizione ed entrare nella nostra condizione storica, nella condizione propria della civiltà. È un cambiamento all'interno delle caratteristiche fondamentali dell'uomo. L'uomo adesso è consapevole della conoscenza del bene e del male. Almeno attenendoci al testo biblico.
C'è pure una contro domanda molto provocatoria che fanno i commentatori: "Ma se l'uomo non conosceva il bene e il male come fa a essere punito per aver peccato? E com'è possibile dire che l'uomo ha peccato?". Però, secondo me, cioè dando questo tipo di lettura, che è la nostra lettura, insomma, la lettura ebraica di questo brano, ci discostiamo da quello che penso essere il tema. Appunto che è quello del peccato originale.
Nell'ebraismo questo non c'è se non in maniera estremamente velata. Cioè c'è scritto che dopo il peccato del vitello d'oro, in qualche modo il popolo ebraico riacquisisce quella condizione posteriore rispetto al peccato originale. Ma si tratta, insomma, di qualcosa di molto più periferico all'interno della nostra tradizione rispetto a quanto non possa essere invece nel mondo cristiano».
Mons. Avondios
«Quello che diceva Biglino riguardo al peccato originale e soprattutto negando l'esistenza del peccato originale, ovviamente non c'è il mandante e non c'è il motivo per cui Gesù è venuto e morto sulla croce.
Qui entriamo in contrasto con l'ebraismo, perché per noi, soprattutto per i cristiani, Gesù è il Messia, per gli ebrei non è il Messia. Anzi, non è mai stato, è il falegname morto, ucciso dai Romani sulla croce per la colpa di aver detto che è il Figlio di Dio.
E la cosa importante, interessante, è che Gesù non l'ha mai detto che è il Figlio di Dio. Lui non l'ha mai detto. Infatti quando lo interrogano: "Tu sei il Figlio di Dio?" lui dice: "Tu lo dici, non lo dico io. E vedrai il Figlio dell'Uomo venendo sulle nubi a giudicare i vivi e i morti".
Il peccato originale, alla fine, cos'è? Perché ci mettiamo sempre questo punto, no?
Il peccato originale è la disobbedienza.
Per esempio, vi faccio un esempio, mi piace sempre fare gli esempi: c'è un signore che ha un grande patrimonio. E ha due figli. E dice a tutti e due i figli: "Guardate, questi miei averi li dovete spartire in due. una a te e una a te".
Uno che è un po' intelligente dice: "Mi faccio forte, quando muore il papà allontano l'altro fratello e mi piglio tutto". E così succede. E dunque ha commesso una disobbedienza a un desiderio del padre.
Tutto quello che lui ha fatto, e tutto quello che ha guadagnato, va avanti per sette generazioni fino a quando, a un certo punto, i pronipoti del fratello lasciato in disgrazia, dicono: "Ma ascoltate, andiamo indietro a guardare un attimo i documenti e anche il testamento. E cerchiamo di riscattare questo blasfemo atto che è stato fatto dal fratello del nostro avo". Esiste dunque una generazione che è rimasta nella disgrazia di non avere, praticamente, degli averi di quello che ha lasciato il capostipite.
Dunque, esiste un peccato, perché è morto Gesù? Gesù è morto sulla croce, se noi guardiamo il capitolo 53 di Isaia, quanti di voi l'avete letto? Isaia 53. E qui sta la cosa molto importante, che il testo che abbiamo noi è molto conforme a quello scoperto a Mar Morto a Qumran. Dunque i nostri fratelli ebrei non sono molto d'accordo sui testi di Isaia, non vedono la messianità di Gesù in questo testo.
Nel testo di Isaia 53: "Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo del dolore che ben conosce il patire". "Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non aveva alcun stima eppure egli si è caricato della nostra sofferenza e si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe. Schiacciato per la nostra iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui.
E dunque tutto questo, vedete, alla fine Gesù è venuto per riscattare che cosa? La nostra disobbedienza. Ecco perché io mi ritrovo nel Gesù morto sulla croce, mi ritrovo e scopro un atto veramente di amore. Ma di amore profondo per tante generazioni di persone che verranno. E la sua morte sulla croce, e la resurrezione, che noi cristiani crediamo, è universale, e dunque vale per tutti e per tutto.
E credo che il punto comune si può scoprire più avanti anche con i fratelli ebrei, perché alla fine non siamo, come diceva Mauro una volta, che siamo dei ladri, che abbiamo rubato i testi agli ebrei e dice: "Ma questi qua cosa vogliono da noi?". No, non abbiamo rubato niente, perché il giudeo cristiano conserva la fede di questi padri eh... il padre soprattutto dell'unico Dio che è il nostro Dio, diciamo, monoteista degli ebrei, dei cristiani e degli islamici».
Daniele Garrone
«Allora, tra Genesi 3 e Romani 5, 12, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea cioè di un atto di decadenza, di un fallimento iniziale dell'umanità, che poi l'avrebbe sempre caratterizzata, dove lo trova in Genesi 3.
Dove, se ve lo leggete a casa, una delle cose che mi ha sempre più colpito è l'atteggiamento di Dio che alla fine non sembra drammaticissimo. Cioè, dice: "Va bene, sono diventati come uno di noi, se stanno ancora nel giardino possono prendere l'albero che li rende oltretutto immortale, mandiamoli via...". Ma si preoccupa persino del fatto che loro si vergognano di essere nudi e li copre. Cioè, non sembra, appunto, una reazione apocalittica.
E in effetti noi oggi leggiamo questi testi come un racconto teologico, cioè un racconto.
Se leggete quella pagina, c'è un bell'articolo scritto anni fa da un collega inglese, Intimacy and Alienation, cioè in Genesi 2 c'è intimità, cioè Dio che passeggia. Al ponentino Dio passeggia la sera nel giardino e Adamo ed Eva non si vergognano, e non c'è inimicizia con gli animali, non c'è ancora il maschilismo, per cui quando Dio porta il prototipo ad Adamo, dice: "Ah! Questa volta sì che ci siamo!", eccetera eccetera.
Invece tutte quelle relazioni in Genesi 3 vengono alterate. Si nascondono da Dio, si vergognano di essere nudi. Adamo diventa un baal, un marito autoritario e c'è il parto con dolore, non è più questa specie di uomo del rinascimento che fa lavori manuali, ma anche comanda il giardino e anche fa lo scienziato, perché dà i nomi agli animali, ma è uno che si deve spaccare la schiena, eccetera, ecco.
Letto sullo sfondo dei miti dei testi babilonesi, è un tentativo di dire: "Ma... nell'andamento del mondo c'è la disarmonia e la fatica del vivere... E se fossero colpa nostra?". Cioè: "E se dipendesse dal fatto che noi non ci accontentiamo di essere quello che siamo? Non sappiamo attenerci ai nostri limiti?".
Potremmo pensare alla categoria moderna dei limite fondante in psicologia. Ci sono dei limiti che ti aiutano... eccetera eccetera. Cioè la fatica e l'ambivalenza e l'ambiguità del vivere dell'umano non sono un destino che gli dèi hanno deciso, ma c'entriamo anche noi, è anche roba nostra.
Il problema è che noi non possiamo né validare né falsificare il cristianesimo, appunto, facendo delle equazioni, perché tra Paolo, l'apostolo, e Genesi 3 c'è tutta una riflessione ebraica, che non è diventata canonica, ma questo non vuol dire niente per me, per il breve discorso che voglio fare, cioè già nella Bibbia ebraica, ma poi successivamente in ambito ebraico, ci si accorge che la visione deuteronomistica diciamo, "Tu sei libero, ti ho messo davanti il bene e il male, scegli il bene onde tu viva...", eccetera eccetera, non basta.
Perché... perché il male seduce? Perché, pur sapendo che una cosa è male, ci vien voglia di farla? Cioè, perché il male è nel mondo?
Sembra qualcosa di più complicato che la semplice somma dei nostri fallimenti, delle nostre nevrosi, delle nostre inettitudini, eccetera eccetera.
Per esempio nel libro dei Vigilanti, che è uno scritto le cui tradizioni sono coeve a parti della Bibbia, ci si inventa una rivolta di angeli - c'è anche poi nel Midrash -, che vengono per punizione cacciati sulla Terra. Cioè hanno fatto disordine in cielo e vengono cacciati giù. E loro per vendicarsi insegnano a fare il male agli uomini.
Allora, queste qui sono storielle, potremmo stoltamente pensare, che ci fanno sorridere, ma hanno la stessa valenza della filosofia di Platone. Cioè sono un modo di chiedersi: ma il male nel mondo è semplicemente la somma dei miei errori o c'è un problema del male?
E allora Gesù è una delle voci che presuppone, in varie interpretazioni della morte di Gesù presuppongono questo drammatico dibattito intra-ebraico e non solo, sulla realtà del male. Allora, letto così voi capite che è molto più semplice che il catechismo ti dice: "Genesi 3:15 più Romani 5:12, a posto". Oppure siccome non funziona quella coppia lì abbiamo risolto il problema? No».
Don Ermis Segatti
«Cerco di fare un bilancio (mi pongo nella tradizione cattolica) di come si è elaborato il concetto di peccato originale, cosa si è detto, con conseguenze talora anche molto tristi.
Si è detto che chi era in sola condizione di peccato originale sarebbe stato destinato all'inferno. Quindi a rigore qui si è giocato, si fa per dire, sul destino di miliardi di uomini di ogni tempo.
Alcuni filoni della teologia cattolica hanno esercitato, diciamo pure, attraverso la questione del peccato originale, e qui mi collego proprio al punto di partenza di noi oggi, un "maneggio" su Dio fuori misura. Hanno supposto di poter decidere il destino dell'umanità con una leggerezza mentale che è preoccupante.
Si fa in fretta a trarre delle conclusioni logiche che poi finiscono per diventare catene sull'uomo, ma prima imprigionano Dio stesso.
Come sopra dicevo: dobbiamo rinunciare ad esercitare una certezza dominativa su Dio.
Qui riaffiora di nuovo il riferimento alle prime pagine di Genesi, con un interrogativo tra i più coinvolgenti: "Ma il male da dove viene?".
Una figura così straordinaria dal punto di vista intellettuale e spirituale, qual è Sant'Agostino, su questo punto fu tormentato per larga parte della sua vita. Lui era, in un periodo della sua giovinezza, manicheo. Diceva, quindi, che il male ha una consistenza, per così dire, paritetica con Dio al punto che la realtà è sovranamente dominata da due entità avverse, un Dio del bene e un Dio del male. Una risposta drastica alla domanda sul male: la sua fonte ultima è in Dio stesso.
Agostino, da convertito definitivamente alla fede cristiana ripudia il manicheismo giovanile come un distorsione di Dio e nello stesso tempo una deresponsabilizzazione dell'uomo. Afferma che il male non esiste in definitiva se non come rifiuto del bene, mentre Dio è solo concepibile in termini di bene assoluto.
Una delle conseguenze di questa visione è la accentuata sottolineatura della colpa umana rispetto alla presenza del male e del peso della colpa di disubbidienza dei primogenitori, il peccato originale appunto. Da ciò sono scaturite teologie, direi, "a rischio".
Dante, ad esempio. Come interpreta la morte di Cristo in croce? Benché, ovviamente, Gesù Cristo sia innanzitutto l'annunciatore del Vangelo, la sua morte in croce è vista come la "giusta" sanazione, cioè adeguata alla sua gravità, della colpa originaria. E ci voleva un Dio tanto grave era.
Qui si inserirebbe un importante confronto anche sulla visione della morte di Gesù all'interno del Corano. Mi riferisco alla lettura della morte in croce di Gesù come viene assunta nella IV Sura al versetto 156 del Corano in cui si nega che veramente Gesù si stato ucciso e sia morto in croce, in quanto Dio lo sottrasse e pose un'altra figura in sua vece, ingannando i suoi esecutori.
Nel contesto della Sura gli Ebrei sono fortemente recriminati appunto per aver creduto di eliminare il Messia, Gesù, figlio di Maria. Il profeta non poteva essere abbandonato da Dio.
Invece la fede cristiana afferma che il Signore redense il male del mondo anche e specificamente attraverso la croce. Cioè, assumendo il male, non infliggendolo. Un aspetto centrale e decisivo intorno alla visione di Dio, della sua onnipotenza e appunto del suo rapporto con il male, che va ben oltre la visione - di cui sopra - sul peccato originale.
Per concludere su questo punto, credo che i testi che si sono citati intorno a questo punto siano profondamente da ripensare, specie nelle elaborazioni che sono state enunciate lungo i secoli da varie teologie. Soprattutto tenendo conto del rapporto di Gesù, nel Nuovo Testamento, con il volto concreto del peccato che è il peccatore, nel quale la responsabilità personale è mai ossessionata da alcuna teoria ereditaria di peccato».
Per continuare a leggere, acquista il libro: