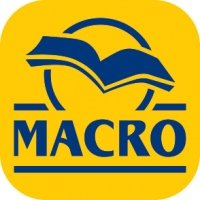Una vitamina tutta da scoprire
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto da "Proprietà e Benefici della Vitamina A" di Simone Grazioli Schagerl
La vitamina A è un micronutriente affascinante, essenziale per tutti i processi vitali: la vista, la crescita, la riproduzione, la funzione immunitaria ecc. A partire dal concepimento, essa regola la divisione e la differenziazione di quasi ogni cellula del corpo. In realtà, “vitamina A” è un termine generico che si riferisce a vari composti liposolubili presenti nei prodotti animali, mentre nei vegetali lo stesso elemento si trova sotto forma di provitamina A o carotenoidi. Le forme attive di vitamina A nell’organismo umano sono il retinolo, il retinaie e l’acido retinoico.
Stai leggendo un estratto dal libro
Nonostante la sua importanza nel mantenere l’organismo in salute, la vitamina A è attualmente un micronutriente poco considerato. Molti ritengono che la sua carenza sia unicamente un problema dei Paesi in via di sviluppo, dando per scontato che in Occidente la grande varietà e disponibilità di cibo assicuri un suo corretto apporto. A livello globale, l’ipovitamino-si A rappresenta davvero un immenso problema di salute pubblica. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che ogni anno tre milioni di bambini sottoalimentati sviluppino una seria carenza clinica di vitamina A, che si manifesta con cecità e un’elevata mortalità sotto i cinque anni di età.
Come tutte le vitamine liposolubili, la vitamina A è immagazzinata nell’organismo al fine di mantenere costanti i livelli necessari alle normali funzioni. Il fegato ne accumula una riserva che può virtualmente durare alcuni mesi; però un’assunzione sovrabbondante per lunghi periodi della vitamina può anche sovraccaricarlo e indurre effetti negativi sulla salute. In particolare, l’eccessivo apporto della vitamina A durante la gravidanza può provocare malformazioni fetali.
Questo spiega perché gli esperti avvertono di mangiare in modo variato e di controllare l’introito di integratori. Come vedremo, ci vuole una certa attenzione per raggiungere livelli ottimali di vitamina A. Si tratta, infatti, di una vitamina un po’ capricciosa.
Un po' di storia
La storia della scoperta della vitamina A merita di essere raccontata. La cecità notturna era già conosciuta dagli antichi Egizi, dai Greci e dai Cinesi, che la curavano con il ricorso al consumo di fegato animale. Un primo indizio sull’esistenza della vitamina risale al 1816, quando il fisiologo francese Francois Magendie osservò che i cani da lui studiati e privati di alcuni nutrienti, svilupparono sintomi simili a quelli dei neonati mal nutriti a Parigi: ulcere corneali e un alto tasso di mortalità.
Questa osservazione però non fu del tutto compresa, in quanto nell’Ottocento si credeva che una dieta completa richiedesse solo i macronutrienti. Cosi si dovette aspettare fino al 1912, quando il medico britannico Frederick Gowland Hopkins dimostrò che minuscole quantità di alcuni fattori reperiti nel latte, erano essenziali per la vita. Per questa scoperta Hopkins ricevette poi nel 1929 il premio Nobel.
Intanto, nel 1913, gli studiosi americani McCollum e Davis avevano chiamato questi fattori vitamina A. Ma occorre aspettare fino al 1931 perché venisse descritta la struttura chimica della vitamina. Durante la prima guerra mondiale, il ricercatore danese Cari Edvard Bloch condusse uno studio clinico sui bambini di un orfanotrofio, trovando che il gruppo alimentato con latte intero, burro e olio di fegato di merluzzo, era protetto dalla cecità notturna. Da allora molti bambini nel mondo hanno ricevuto un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo ogni giorno.
Negli anni Trenta si scoprì poi anche il ruolo del beta-carotene (o P-carotene) come precursore della vitamina A. La sintesi del retinolo fu invece realizzata nel 1947 dallo svizzero Otto Isler. In seguito, fu rilevato il meccanismo molecolare della vitamina A nella visione. Dagli anni Sessanta del Novecento in poi si iniziarono a trattare i disturbi da carenza di vitamina A nei Paesi in via di sviluppo e allo stesso tempo calò però l’interessamento per tale vitamina in Occidente.
Per la gioia dei bambini, l’impiego dell'olio di merluzzo cadde quindi in disuso. Solo le recenti entusiasmanti scoperte su questa vitamina e il suo ruolo simil-ormonale e protettivo nei confronti dell’autoimmunità, dei tumori e delle allergie, hanno riacceso la considerazione per questo gruppo di molecole che orchestra l’azione di oltre cinquecento geni nel corpo umano.
La Vitamina A e la vista
Dopo il fegato, il distretto organico più ricco di vitamina A è la retina. La vitamina A infatti si chiama “retinolo”, e ciò rispecchia bene la sua importanza per la vista e la salute degli occhi: letteralmente non possiamo vedere senza la vitamina A!
La retina si trova nella parte posteriore del bulbo oculare dove rappresenta la componente sensoriale. E costituita da cellule nervose specializzate che elaborano l’energia luminosa e trasmettono i potenziali d’azione attraverso il nervo ottico al cervello. La retina è composta di due tipi di fotorecettori: i bastoncelli e i coni. Ci sono circa centoventi milioni di bastoncelli e sei milioni di coni in ciascun occhio. Mentre i coni sono responsabili della visione diurna e della percezione dei colori, i bastoncelli sono più attivi nell’oscurità e sensibili solamente al movimento. Di notte infatti vediamo in bianco e nero.
La molecola deputata a ricevere l’impulso luminoso è la rodopsina, un pigmento costituito da due parti: l’opsina e il retinolo. L’esposizione alla luce consente al retinolo di cambiare la sua configurazione da trans-retinica a cis-retinica. Per farvi capire, si tratta solo di un piccolo “piegamento” della molecola di appena quarantacinque gradi. Tuttavia, esso è sufficiente per innescare una cascata di processi che portano alla trasformazione dell’impulso luminoso in segnali elettrici, che si propagano fino alla corteccia visiva, che li traduce in immagini. È attraverso e secondo la struttura dell’opsina che percepiamo i vari colori, che non sono nient’altro che luce in diverse lunghezze d’onda.
Il processo della visione dipende dunque dalla vitamina A, la quale, consumandosi, rigenera la rodopsina. Quando la sera al buio siamo improvvisamente colpiti da una luce molto intensa, possiamo rimanere abbagliati per qualche secondo, perché l’adattamento alla luce dipende dalle riserve di vitamina necessarie per il riciclo della rodopsina.
L’incapacità di vedere bene di notte e di adattarsi rapidamente dalla luminosità all’oscurità sono da considerare i primi segni di una carenza latente di vitamina A. Più marcata è la difficoltà di abituarsi al buio, maggiore sarà la carenza. Ma perché la visione notturna è compromessa prima di quella diurna? Non lo sappiamo di preciso.
Probabilmente conta il fatto che i bastoncelli sono più numerosi e si consumano più facilmente nello sforzo di captare segnali luminosi anche minimi. Tutto ciò richiede infatti più retinale.
La vitamina A influisce pure su come percepiamo la luce naturale del giorno. Poiché i coni deputati allo spettro blu sono, dopo i bastoncelli, i più sensibili alla carenza del retinolo, la percezione di questo spettro è la prima a essere compromessa. Non smettiamo di vedere il colore, ma tutto ci sembra meno luminoso, meno colorato, meno entusiasmante. Ciò potrebbe influenzare l’umore e più ancora i bioritmi circadiani.
Se l’occhio non riceve abbastanza frequenze dello spettro naturale durante il giorno, in particolare nella mattinata, il bioritmo del sonno-veglia può essere disturbato. Del resto possiamo anche sviluppare dei disturbi del sonno quando ci esponiamo poco alla luce naturale e non assumiamo abbastanza vitamina A. D’altronde passiamo molte ore davanti agli schermi, esposti a troppe frequenze di luci blu. A ciò si aggiunge l’esposizione alle luci LED, sempre più diffuse nelle nostre case.
Nonostante la luce LED ci appaia bianca, il suo spettro di emissione ha un gran picco alle lunghezze d’onda corrispondenti a quelle della luce blu. Sono proprio le frequenze blu a risultare le più dannose. Ecco perché è importante scegliere le lampadine LED dalle tonalità più calde e installare dei sistemi di protezione per gli schermi.
I fotorecettori, difatti, non hanno scelta, assorbono sempre la luce che li raggiunge. I danni causati dall’esposizione eccessiva alla luce sono di natura ossidativa e colpiscono perlopiù il retinale e con esso innanzitutto i bastoncelli.
I primi sintomi della carenza di vitamina A sono l’adattamento al buio alterato, la cosiddetta cecità notturna, e la ridotta produzione di fluido lacrimale. Nella fase successiva diminuisce la vista in generale, la cornea diventa man mano sempre più secca e infiammata, fino a perdere la sua trasparenza, una condizione chiamata xeroftalmia, che porta alla cecità se non viene trattata in tempo.