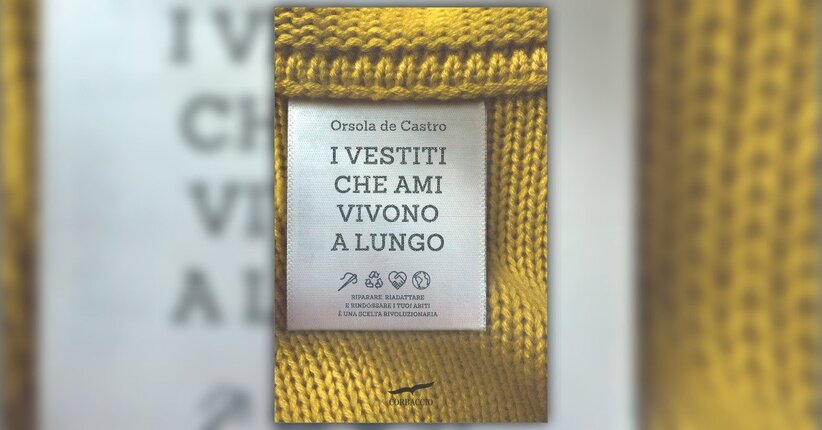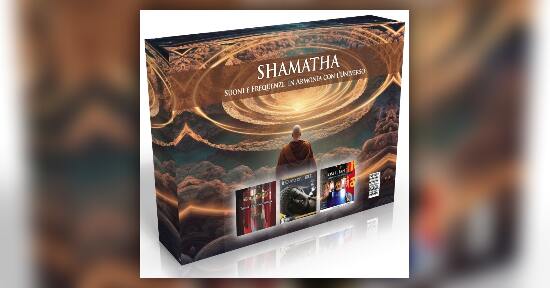Ripara, riadatta, rindossa
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto da "I Vestiti che Ami Vivono a Lungo" di Orsola De Castro
La moda non è frivola, anzi, ha un’importanza fondamentale, e definirla solo come una serie di tendenze passeggere significa negare il suo ruolo nella cultura e nella storia umana.
I vestiti sono sempre stati al centro della nostra esistenza: contrassegnano i nostri rituali, rappresentano identità, professione, il rango e lo status di ciascuno di noi, ma hanno anche profonde implicazioni sociali. Spesso quello che indossiamo ci avvicina ad altri che vestono in modo simile al nostro, aiutandoci a identificare la nostra comunità, a creare connessioni e a provare un senso di appartenenza.
Fin da quando l’istinto primordiale di coprire il nostro corpo si è evoluto nel concetto più sofisticato di ornarlo, abbiamo sempre avuto a cuore il nostro modo di vestirci ed è un interesse che continua ad appassionarci.
Oggi quella della moda è un’industria gigantesca, un labirinto di supply chain, le catene di produzione e distribuzione, separate fra loro che coinvolgono molte altre industrie, dall’agricoltura alla comunicazione, interessando il cento per cento della popolazione e toccando in egual misura vite, risorse naturali, luoghi e persone.
Nel solo Regno Unito l’industria della moda vale all’incirca 32 miliardi di sterline, per più di 850.000 posti di lavoro. A livello globale si parla di un business da più di 2400 miliardi di dollari, una produzione a ciclo continuo di camicie e camicette, abiti, giacche, pantaloni, T-shirt, scarpe, borse e bikini, quasi tutti uguali e spesso sfornati dalle stesse enormi aziende della moda a basso prezzo e del lusso.
La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, per non parlare dello sfruttamento sociale. Il suo impatto economico e ambientale è vastissimo, la sua potenziale influenza sulla cultura illimitata.
La moda non ha nulla di superficiale: scava nel profondo e parla di noi, di chi siamo e dello stato della nostra civiltà, ma anche dei nostri gusti personali e delle nostre tradizioni locali.
Troppo spesso associata a passioni effimere e al lavoro femminile, la moda è un bersaglio facile per chi non vuole prenderla sul serio. In realtà gioca un ruolo molto importante nel grande ordine delle cose, e l’attuale industria del fashion nasconde dietro la sua facciata gloss and glamour segreti oscuri e inquietanti.
Le statistiche hanno del grottesco: nonostante indossiamo i nostri vestiti sempre di meno, conservandoli nascosti e inutilizzati in fondo all’armadio o sbarazzandocene senza guardare alle conseguenze, negli ultimi quindici anni la produzione di abbigliamento è raddoppiata.
Come risultato, dei presunti 53 milioni di tonnellate di capi prodotti globalmente ogni anno, più del 75% viene buttato via, in fase di produzione oppure dopo che li abbiamo indossati: l’equivalente di un camion della spazzatura che riversa in discarica un carico di vestiti usati al secondo.
Il destino degli indumenti a buon mercato è segnato dal momento stesso in cui lasciano la fabbrica, ed è degno di una favola inedita dei Fratelli Grimm: nati nello squallore, acquistati in fretta, indossati una sola volta (magari nemmeno quella) e, per finire, buttati in spazzatura. il nostro prêt-à-porter è diventato un prêt-à-jeter.
Karl Marx ha detto che la religione è l’oppio dei popoli: aggiorniamo il concetto, e diciamo che il consumismo odierno è il nostro crack.
Quanto ai vestiti costosi, non è detto che siano stati fabbricati con più cura: perché anche il settore del lusso danneggia l’ambiente e sfrutta la manodopera, e sarebbe un grosso sbaglio illudersi che, solo perché un prodotto costa di più, i suoi profitti siano distribuiti in modo più equo lungo la catena produttiva.
A parte il cartellino del prezzo, tra l’abbigliamento cheap e il fast luxury non c’è poi tanta differenza. È l’industria della moda nella sua interezza a essere chiamata in causa, proprio come la nostra sete insaziabile di oggetti, sempre nuovi, sempre di più.
Non possiamo andare avanti così, perché le nostre risorse non sono infinite e presto la disponibilità sarà limitata.
Se vogliamo ridurre in modo drastico la nostra dipendenza dai combustibili fossili, il poliestere diverrà più costoso della seta, e per quanto riguarda il cotone, il suo prezzo schizzerà alle stelle quando verrà a mancare il suolo dove coltivarlo.
«Sostenibilità» adesso è un termine molto in uso, ma cosa significa davvero nell’ambito dell’abbigliamento? Quali scelte può fare ognuno di noi – e dico ognuno perché tutti indossiamo qualcosa – per smettere di essere parte del problema e diventare invece parte della soluzione?
Sarebbe sbagliato pensare alla sostenibilità come a una tendenza passeggera, anzi è vero proprio il contrario: in quanto essenziale per la nostra sopravvivenza ed evoluzione, la sostenibilità è una tendenza da centinaia di migliaia di anni.
Sostenibilità significa equilibrio, qualità e rispetto. Non ci nega nulla e ci fornisce tutto. Ci parla di gratitudine invece che di avidità, d’intraprendenza invece che di sfruttamento.
L’autrice e attivista Dominique Drakeford definisce la sostenibilità «un meccanismo rigenerativo intrinsecamente nero, marrone e indigeno, per vivere e relazionarsi con la Natura».
L’eccesso, ecco cosa fa tendenza, ma è una tendenza di cui dobbiamo disfarci al più presto, se non vogliamo diventare gli strumenti della nostra stessa fine.
Possiamo tutti contribuire al cambiamento, semplicemente riparando, riadattando e rindossando. Bisogna modificare il modo di pensare, non nel senso di godersi meno le cose, ma di goderne in modo diverso.
Applicato al nostro guardaroba, questo significa riappropriarci dei nostri vestiti e rinnovarli per dare forma alle nostre intenzioni.
Possiamo imparare a considerare le limitazioni non come delle restrizioni, ma come un modo per stimolare soluzioni alternative. Possiamo porci la sfida di vedere imperfezioni e difetti come opportunità di miglioramento, invece che come motivi per scartare.
Se siamo capaci d’imparare dai nostri errori, allora un indumento rovinato e rimesso a nuovo può diventare il nostro statement piece preferito, un pezzo audace, che parla di noi.
Non occorre andare molto lontano per imparare a far durare di più i nostri vestiti: basta una piccola marcia indietro generazionale, poiché riutilizzare e riciclare sono concetti vecchi come il tempo, il know-how è impresso in tutte le culture ed è innato in ciascuno di noi. Solo che adesso benefici e implicazioni sono più rilevanti che mai.
Possiamo fare dei vestiti usati una metafora per esprimere le nostre idee politiche (basti pensare ai Sex Pistols, alle magliette con gli slogan, alle spille, alle scritte, alle toppe, ai berretti rosa con le orecchie, agli arcobaleni) e come uno strumento per ridurre l’impronta di carbonio, visto che riadattare e rindossare incoraggia un consumo più consapevole alimentando la cultura dell’apprezzamento a discapito di quella dello sfruttamento.
Le azioni da intraprendere sono facili, niente che ciascuno di noi non possa affrontare, e ripagano ampiamente dell’impegno richiesto. La cosa importante è iniziare subito, ciascuno al proprio ritmo e secondo le proprie capacità, e incominciare a sperimentare cosa si prova a vestirsi di idee nuove e abiti vecchi.
Questo libro è un incitamento a servirci dei nostri indumenti – e degli strumenti che li fanno durare più a lungo – come di un’armatura, compiendo il gesto rivoluzionario di ripararli.
In questo momento critico, al bivio tra evoluzione ed estinzione, una strada porta alla salvezza e l’altra alla rovina. Dobbiamo fare quanto ci è richiesto in veste di cittadini, cioè passare all’azione, e ogni tipo di azione, piccola o grande che sia, è benvenuta e necessaria.
Questo non è un manuale sul «come fare», ma un libro sul «perché fare»: un libro per riparare vestiti e creare cambiamenti.
Per continuare a leggere, acquista il libro