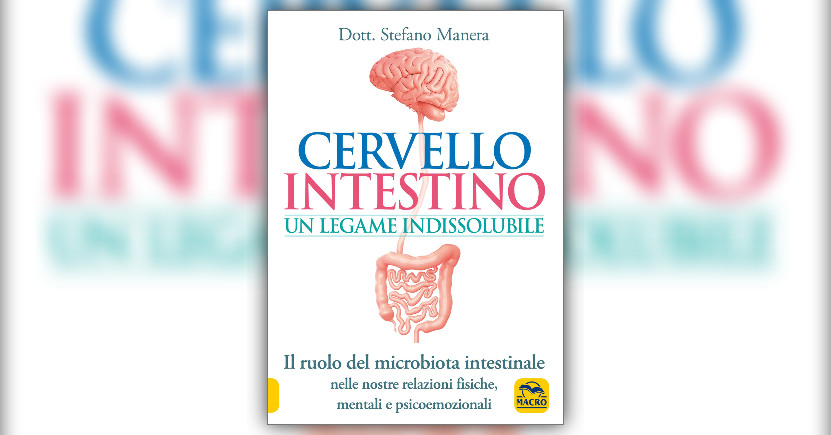Mente e corpo: un'unità
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto da "Cervello Intestino: un Legame Indissolubile" di Stefano Manera
Sin dalla notte dei tempi, l’uomo ha sempre considerato il corpo e la mente all’interno di una concezione dualistica, ovvero come elementi tra loro indipendenti, per poter spiegare fenomeni che altrimenti non sarebbero stati compresi, come i pensieri, il dolore fisico e la morte.
Il dualismo consentiva anche di distinguere gli esseri viventi da quelli non viventi e, in termini più ampi, di poter esprimere più semplicemente concetti morali, religiosi e filosofici. La distinzione tra mente e corpo, cioè la visione dualistica, senza dubbio fu molto chiara inizialmente, addirittura lineare, ma per molti filosofi parve poco convincente.
Anticamente la mente e l’anima erano considerate essere la stessa cosa: era l’anima che distingueva l’uomo dagli animali e che lo rendeva un essere pensante; ed era ancora l’anima che “animava” un essere non vivente, portandolo alla vita.
Ad esempio, Aristotele, Ippocrate, Giovenale e san Tommaso d’Aquino consideravano il corpo naturalmente abitato da una forza spirituale, appunto l’anima, e non avevano una visione dualistica.
Nelle Satire di Giovenale (redatte dopo il 127 d.C.) si legge la famosa locuzione mens sana in corpore sano (mente sana in corpo sano), con essa intendendo che, per aver sane le facoltà dell’anima, bisogna aver sane anche quelle del corpo. Giovenale riteneva che mente e corpo fossero distinte, ma strettamente interconnesse.
Nella tradizione cristiana, anima e corpo furono sempre considerati distintamente con precise caratteristiche morali, in una visione dualistica molto evidente nelle usanze di mortificare e punire il corpo per elevare maggiormente l’anima verso Dio, separando cioè ciò che era considerato terreno, quindi peccaminoso, da ciò che era considerato puro.
San Tommaso sosteneva che l’anima sopravvivesse al corpo dopo la morte, ma che fosse destinata a unirsi nuovamente a esso, in occasione della risurrezione finale dei corpi, poiché nella sua interpretazione filosofica e teologica, sarebbe stato inconcepibile considerare la forma senza la materia e la materia senza la forma, ovvero corpo e spirito separati.
Da un punto di vista storico, il dualismo corpo-mente è stato per lungo tempo visto nell’ottica del dualismo materia-spirito e il maggior responsabile di questo modo di vedere la realtà è stato certamente Cartesio, che definì l’anima come res cogitans in opposizione al corpo definito come res extensa. Questa tesi fu considerata ben presto insostenibile e gli studiosi della mente dell’ultimo secolo identificarono e sottolinearono tale errore gnoseologico in maniera molto precisa, come ha fatto ad esempio Antonio Damasio, dedicando a questo argomento un intero saggio.
La teoria cartesiana, tuttavia, ebbe molto successo nelle teorizzazioni etiche e pedagogiche sino agli inizi del XX secolo. La concezione di un’anima intelligente che dirige il corpo, semplificava molto l’etica, la prassi educativa e le regole religiose attraverso la contrapposizione tra spirito e carne: le persone dovevano essere educate a dominare le esigenze del corpo attraverso la volontà. Le azioni umane venivano interpretate e giudicate come atti dettati esclusivamente dal libero arbitrio.
Stai leggendo un estratto da:
L'unità psicofisica
Nel XIX secolo accadde però qualcosa di nuovo: l’attenzione cominciò a rivolgersi ai rapporti tra corpo e spirito e sempre meno alla loro opposizione. In quegli anni venne teorizzato il concetto di unità psicofisica per indicare quella connessione esistente tra gli stimoli recepiti dal corpo e la percezione a livello di coscienza e, viceversa, la connessione tra sentimenti, stati d’animo e traumi psichici nel comportamento somatico.
Prese quindi corpo il concetto di unità psicofisica partendo dalle ricerche di Gustav Theodor Fechner sui fenomeni psicofisici, sulla sensazione e sulla percezione.
Il biennio 1860-1861 fu un periodo importante poiché, innanzi tutto, fu elaborata la famosa legge di Weber-Fechner, ovvero uno dei primi tentativi di descrivere la relazione tra stimolo e percezione, e in secondo luogo perché furono scritti da Fechner stesso due importanti saggi: Elementi di psicofisica (1860) e Sul problema dell’anima (1861).
Ma fu solo agli inizi del XX secolo che si ebbe la svolta significativa rispetto al problema dell’unità psicofisica attraverso molteplici autori e i loro relativi lavori; pensiamo a William James e a Sigmund Freud, l’“ideatore” della psicoanalisi, disciplina in cui l’interesse per il corpo e per la relazione corpo-mente è presente fin dalla sua nascita attraverso lo studio sulle pulsioni. Ma pensiamo anche agli studi sulla psicogenesi delle forme del pensiero, al cognitivismo di Jean Piaget, agli sviluppi della medicina psicosomatica, alla filosofia energetistica di Henri Bergson, alla teologia evoluzionistica di Teilhard de Chardin e alla fenomenologia a partire da Edmund Husserl in poi.
La psicologia studia la coscienza senza riferirsi a organi del corpo o a componenti microscopici dell’organismo umano, come neuroni e gangli, ma a esperienze vissute dall’individuo che è considerato come una realtà fisica, vivente, che parla e agisce.
Oggi sappiamo che l’esperienza non esiste in sé, ma è un vissuto soggettivo e individuale. Fu questo l’errore in cui cadde Cartesio definendo il pensiero come res cogitans.
Il nostro bisogno di avere delle definizioni si esprime con identificazioni e riferimenti a cose e a situazioni intese oggettivamente; in questo modo; la coscienza diviene necessariamente qualcosa di estraneo al corpo e al quale dovrà essere necessariamente collegata.
Vivere è conoscere
La realtà è invece che la coscienza non è assolutamente estranea al corpo, ma è un tutt’uno. È così che nasce il concetto di unità psicofisica: coscienza e organismo fisico non sono due realtà a sé stanti, e di cui dobbiamo studiare le reciproche influenze, ma costituiscono la stessa realtà umana vissuta dal soggetto.
Abbiamo sentito spesso proferire distinzioni come: sofferenze dell’anima e del corpo, educazione della mente e del corpo, malattie mentali e malattie fisiche e così via. Tutte queste espressioni, tuttavia, sono estremamente devianti perché inducono a credere che mente e corpo siano ambiti separati e, magari, meritevoli di cure e attenzioni distinte.
L’unità psicofisica è invece il nuovo modo di considerare l’uomo in contrapposizione al dualismo psicofisico, concetto che ha preso corpo sostanzialmente a causa delle carenze e dei limiti del linguaggio umano, il quale non può parlare degli stati soggettivi se non attraverso l’oggettivazione; ed è proprio così che la coscienza diventa una res (per quanto cogitans) in opposizione al corpo.
Un importantissimo contributo nella comprensione dell’unità psicofisica fu dato intorno al 1970 da due importanti ricercatori: Humberto Maturana e Francisco Varela. Essi sostanzialmente ridefinirono il concetto di “essere vivente”, estrinsecando il concetto più ampio di “cognizione”.
La cognizione per Maturana e Varela non era più una “funzione” del vivente, ma il vivente stesso. Questo concetto verrà poi sintetizzato nella formula vivere è conoscere.
Ci troviamo pertanto in un punto di incontro inevitabile tra teoria della conoscenza, teoria della scienza (epistemologia), e scienza biologica stessa, tanto che Maturana stesso parlerà in seguito di biologia della conoscenza.
Nel corso della storia, tuttavia, non tutto fu sempre così semplice e lineare, tanto è vero che il cosiddetto problema mente-corpo è emerso sin da tempi molto antichi.
All’interno di questa grande problematica filosofica è possibile individuare due grandi correnti. La prima sostiene che l’organismo umano consiste in un’unica realtà, basata su una sola sostanza fondamentale, in cui mente e corpo sono parti differenti ma correlate.
La seconda afferma invece che mente e corpo sono elementi ben distinti e vanno pertanto considerati separatamente. In parole povere, le cellule del sistema nervoso centrale (i neuroni) e le importantissime sinapsi (siti elettivi di connessione e interazione nervosa) avrebbero un livello di complessità troppo differente dalle altre cellule del corpo perché si possa prendere in considerazione una visione unitaria. Questa tesi non esclude in realtà l’unità di corpo e mente, ma più semplicemente ritiene che, da un punto di vista gnoseologico, la fisiologia del corpo e del cervello siano profondamente distinte, ovvero che corpo e mente agiscano su livelli separati.
Due correnti di fondo molto diverse quindi, ma dalle quali hanno preso corpo molte posizioni, da quelle più scientifiche (che appaiono oggi dominare), come il fisicalismo o materialismo, e le dottrine non-fisicaliste, come ad esempio quella del premio Nobel per la medicina Gerald Edelman, ideatore del darwinismo neurale.
In un ventaglio così ampio di teorie e posizioni, agli estremi troviamo la visione scientifica riduzionistica (lo scientismo) e la visione metafisica.
Gli "stati esperienziali"
L’uomo viene considerato dai filosofi contemporanei in un’ottica di sempre maggior complessità caratterizzata da un dualismo delle proprietà o delle funzioni, e dunque non più ontologico.
In questa visione dell’uomo, mente e corpo non sono due elementi separati, ma compenetrati e coniugati funzionalmente. Mente e corpo possono quindi esser visti anche come “stati esperienziali” di un organismo polifunzionale, in cui è possibile distinguere gli stati fisiologici e quelli cerebrali, legati alle strutture neurologiche del-la sensibilità corporea, e gli stati mentali, cioè quelli che realizzano esperienze come le emozioni, i sentimenti e l’elaborazione del pensiero.
Il filosofo e genetista Edoardo Boncinelli, distinguendo tra neurostato (fenomeno cerebrale) e psicostato (fenomeno mentale), ha scritto: «In un determinato individuo e in un determinato momento, a un neurostato corrisponde uno psicostato, ma lo stesso psicostato può corrispondere a molti, o moltissimi, neurostati diversi. Da un certo punto di vista ciò è scontato. Noi non sappiamo dire quanti psicostati possano esistere nella nostra mente, non fosse altro perché non sappiamo bene che cosa siano, ma intuiamo che il loro numero non può essere altissimo. Non ci sarebbero infatti abbastanza strumenti interpretativi. Non sappiamo dire neppure quanti possano essere i neurostati concepibili, ma è facile supporre che saranno in numero incredibilmente alto. Se consideriamo anche solo le configurazioni delle singole sinapsi il loro numero è impressionante».
Oggi possiamo sicuramente dire di aver compreso molto sul mistero di mente e corpo che da sempre impegna e divide pensatori, filosofi e studiosi. Abbiamo infatti capito che essi costituiscono un’unità e che un terapeuta non può esimersi dal curare simultaneamente entrambi per poter avere una efficacia terapeutica elevata. Rimangono tuttavia aperti alcuni quesiti:
- Che cos’è uno stato mentale?
- Che rapporto c’è tra uno stato mentale e uno stato cerebrale?
- Come può il cervello dare luogo a stati mentali?
Sempre Edoardo Boncinelli (e come lui molti altri studiosi), ne fa una questione di tempi e di complessità, vedendo lo stato cerebrale come l’elemento semplice e primario, la sede delle funzioni biochimiche e lo stato della mente come l’elemento complesso e secondario, non più relegato solamente al cervello, ma appartenente alla complessità dei processi cognitivi più elevati.
In questo ambito le risposte a questi interrogativi variano col variare della nostra visione del mondo, della causa che sposiamo, della natura della mente e del cervello stesso.
«L'evento fisiologico iniziale comprende elementi molecolari, cellulari e circuitali e coinvolge vari sistemi somatici fra i quali certamente quello nervoso a ciascuno dei suoi livelli. Nonostante la pluralità di coinvolgimenti, l'evento fisiologico iniziale è istantaneo e inconsapevole. A questo seguono quasi sempre molte altre cose: una presa di coscienza, una valutazione emotiva, un'elaborazione mentale».
Per continuare a leggere, acquista il libro