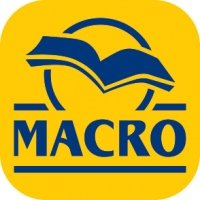Ecco perché costruire laghetti in permacultura nel tuo orto o giardino
Pubblicato
3 anni fa
Rendono piacevole il paesaggio, creano biodiversità, mitigano il clima e ridanno vita ai territori desertici: ecco come progettarli al meglio
Come ogni estate si torna a parlare di problemi di approvvigionamento idrico, di manutenzione della rete idrica, di siccità; il tutto collegato agli allarmi per il cambiamento climatico. E come ogni anno si corre ai ripari con soluzioni emergenziali, che spesso non fanno che aggravare i problemi.
L’acqua è il nodo di tutto. Come scrive giustamente il contadino ribelle, il permacultore austriaco Sepp Holzer, nel suo libro Come trasformare il deserto in paradiso: «La chiave per la stabilità climatica è l’acqua. L’acqua è il capitale più prezioso di un paesaggio. Se non c’è acqua, anche il miglior suolo è inutile per il contadino».
E proprio Sepp Holzer ci spiega come rinaturalizzare i paesaggi attraverso l’acqua, cioè restituendo al suolo la sua umidità naturale. E lo fa insegnandoci a leggere la natura, a osservarla per cercare di capire se ci stiamo comportando bene nel ciclo naturale o se siamo invece gli elementi che ne turbano l’equilibrio. Holzer ci insegna che è possibile tornare indietro, cioè recuperare territori anche ormai desertici, rendendoli nuovamente fertili.
Una gestione idrica naturale
Per farlo occorre, con umiltà, tornare a prendere lezioni dalla natura e molto spesso occorre dimenticare quanto imparato nelle università, infatti, come spiega lo stesso Holzer «all’università non si insegnano i principi di una gestione idrica naturale: molte delle cose che spiego e dimostro sono completamente nuove per gli idrologi e gli ingegneri idrici e contraddicono tutte le teorie riconosciute dalla comunità scientifica. La cosa non sorprende, perché in ambito accademico l’acqua non è considerata qualcosa di vivo in cui ci si deve immedesimare, ma soltanto una formula chimica. Invece, solo se la si tratta come un organismo vivente si riesce a capirla, a indirizzarla e a collaborare con essa».
Osservando la natura, invece, si comprende come emularla, si capisce quali sono i principi fondamentali da rispettare, quali ruoli svolgono i vari protagonisti. Dovremmo comprendere, ad esempio, quale ruolo svolge il suolo. Questo – continua Holzer – «allo stato naturale si impregna di acqua e la cede a tutte le creature viventi che ne hanno bisogno: esseri umani, animali e piante. Dove è stata annientata l’umidità naturale del suolo, l’uomo dovrà intervenire per correggere gli errori del passato. Deve farlo prima che la terra si trasformi in deserto, e può riuscirci creando paesaggi acquatici decentrati conformi alla natura. Un’area di ritenzione idrica, e dunque un bacino di conservazione per l’acqua piovana non impermeabilizzato e creato seguendo il modello naturale, ha un effetto stabilizzante sul clima: raccoglie l’acqua piovana e le permette di penetrare di nuovo lentamente nel suolo».
Quindi le impermeabilizzazioni dei bacini di ritenzione tramite teli di plastica o cemento sono, non solo superflue, ma anche controproducenti. La natura ci insegna infatti che l’acqua deve penetrare nel suolo per poter ristabilire il bilancio idrologico. L’acqua è per sua natura incline allo scambio e non all’isolamento.
Laghi e stagni per il riequilibrio climatico
La natura ci mostra anche che «quando il sole estivo irradia il suo calore su un paesaggio di laghi e stagni, anche se l’acqua si riscalda in superficie, in profondità rimane comunque fresca. Di notte cede lentamente il calore accumulato, e con l’evaporazione e la condensazione della rugiada tutta l’area ne trae refrigerio e umidità diffusa. Un sistema di bacini di ritenzione idrica è la premessa, se non la base stessa, per la creazione di un sano bosco misto che, ricevendo sufficiente umidità dal basso, trasforma acqua e calore in energia e crescita.
Così un paesaggio acquatico e la vegetazione che cresce in questo ambiente sono in grado di compensare anche una forte calura e portano al clima equilibrio e stabilità.
Questo tuttavia non vale se ho un grande specchio d’acqua privo di vegetazione, un lago squadrato o perfettamente rotondo senza zone più o meno profonde, oppure una diga di sbarramento centrale. Questo bacino d’acqua si riscalderà facilmente per poi raffreddarsi senza esercitare un effetto di compensazione, perché l’acqua non si muove e non dà luogo a un efficace scambio termico».
Bacini idrici all’insegna della biodiversità
Quindi un bacino di ritenzione idrica non deve essere un invaso artificiale, anzi, l’esatto contrario. La natura prevede dislivelli, zone piatte e zone profonde, ombra, forme diverse: la natura prevede biodiversità. «Un bacino di ritenzione idrica – scrive Holzer – è un sistema all’insegna della biodiversità: varie profondità, numerose forme di piante e terrazze, molti esseri viventi. Più un sistema è vario, più è stabile».
Imparare a “lavorare” in maniera naturale con l’acqua ci può aiutare non solo a non avere problemi di approvvigionamento idrico e a rinaturalizzare territori, ma potremmo addirittura recuperare terreni che il comportamento irresponsabile dell’uomo ha reso desertici.
E conclude: «Senza una progettazione conforme alla natura, l’acqua si limita a vegetare, ma non bisogna privarla della vitalità».