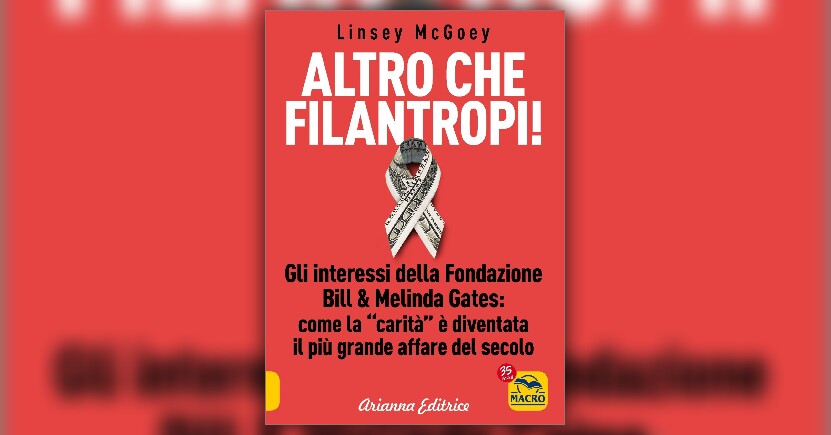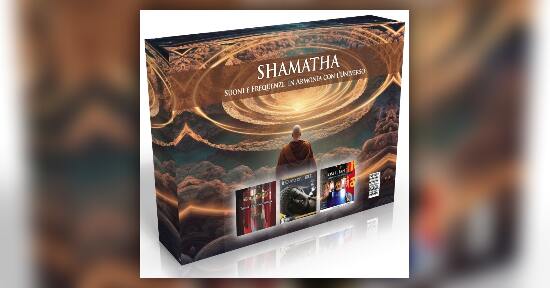La filantropia: una generosità disinteressata?
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto di "Altro che Filantropi" libro di Linsey McGoey
Questo libro persegue due tesi principali.
Per prima cosa aggiungo una contestualizzazione di tipo storico agli obiettivi dichiarati dai moderni filantrocapitalisti, mettendo in evidenza le similitudini tra la loro condotta e quella di alcuni loro predecessori come Carnegie e Rockefeller.
In secondo luogo mi propongo di esplorare le ramificazioni su come i dollari che vengono oggi donati in beneficenza vengano effettivamente investiti, questione il più delle volte ignorata o sottaciuta.
Che tipo di influenza esercitano sulla politica questi ricchi benefattori? Quali sono gli aspetti positivi e quali i negativi di soggetti privati che possono spesso contare su ricchezze più grandi del Pil di molte nazioni e che esercitano forti pressioni per azioni nel campo della sanità, dell'istruzione e dell'agricoltura da implementare sia sul piano interno che estero?
I fautori del filantrocapitalismo dichiarano spesso che un modello di business applicato al settore della beneficenza sia qualcosa di mai visto prima.
Nel 1999, per esempio, i famosi studiosi di gestione aziendale Mark Kramer e Michael Porter pubblicarono un articolo sull'«Harvard Business Review» in cui teorizzavano che troppo poche fondazioni «avessero un piano strategico su come valorizzare al massimo il proprio impatto sulla società partendo dalle risorse a loro disposizione. Un impegno troppo modesto viene dedicato al controllo dei risultati concreti sul campo. Anzi, spesso le fondazioni non ritengono nemmeno che vi sia una correlazione diretta tra il riscontro di quanto ottenuto e l'operato svolto nell'ambito della beneficenza».
Questa considerazione è semplicemente non corrispondente al vero. In realtà infatti un modello di beneficenza organizzata su larga scala che ricalcava le strategie del business industriale esisteva da almeno 120 anni, da quando magnati come Carnegie e Rockefeller avevano dichiarato apertamente che avrebbero agito nell'ambito della carità esattamente come avevano fatto coi loro affari.
Prendete ad esempio il principale consigliere di Rockefeller per gli affari legati alla beneficenza, l'ex pastore battista Frederick T. Gates. Nel 1888, Gates lasciò il ministero spirituale per assumere la carica di consulente prima per Rockefeller padre e poi per il figlio John D. Rockefeller Jr., col compito di gestire nel miglior modo possibile i loro affari nel settore.
Gates era uno dei massimi esponenti del Movimento efficientista, una scuola di pensiero che si proponeva di applicare i principi della gestione industriale taylorista a tutti gli aspetti della vita sociale ed economica. Gates suggeriva insistentemente a Rockefeller di calibrare i suoi investimenti in tal senso per ottenere risultati che fossero il più evidenti e verificabili possibile, per esempio nella lotta a malattie capaci di uccidere o recare comunque grossi danni ai più deboli.
Come fa notare il sociologo Nicolas Guilhot, tanto Rockefeller Sr. quanto Andrew Carnegie sostenevano di «applicare i metodi razionali del business all'amministrazione di opere caritatevoli, che consideravano fino ad allora organizzate secondo logiche obsolete e deficitarie».
William Schambra, direttore del Centro Braley per la filantropia e il rinnovamento civico dell'Istituto Hudson, mi ha ribadito personalmente tale concetto in un'intervista: «Il principio secondo cui dovremmo organizzare le opere di carità sul modello delle grandi aziende proviene da un'idea originale di John D. Rockefeller. Dare vita a una sorta di struttura industriale sia sul versante gestionale che su quello prettamente decisionale. [Il filantrocapitalismo] va però oltre ciò».
Quando i fautori del filantrocapitalismo dichiarano che la "nuova" beneficenza sarebbe maggiormente orientata a ottenere risultati concreti oppure meglio organizzata (secondo le logiche del business) rispetto a quella del passato, stanno evidentemente ignorando l'esistenza o l'eredità di movimenti come il già citato Efficientismo, che già ai suoi tempi era praticamente ossessionato dalla misurazione oggettiva dell'impatto delle proprie opere sulla società.
Lo storico Stanley Katz ha trattato con schiettezza l'argomento. «Gran parte dell'odierna retorica delle opere di beneficenza», scrive, «sembra tradire una grave mancanza di conoscenza della storia delle grandi e importanti fondazioni di carità statunitensi»
Se allargate lo sguardo ancora più indietro, verso il Settecento, le similitudini tra i filantrocapitalisti di oggi e i loro antichi predecessori risulteranno ancora più evidenti.
Un punto fondamentale della "nuova" filantropia è che mercati e principi morali non sarebbero fenomeni distinti tra loro, ma al contrario con diversi punti di contatto. Servendosi della potenza del mercato, il filantrocapitalismo mira come obiettivo naturale a influire sulla condizione sociale di fasce di popolazione sempre più vaste: un concetto senza dubbio potente, ma non nuovo.
Al contrario, riecheggia antiche teorie sui benefici che l'impresa privata esercita su tutta quanta la società. In un certo senso, potrebbe essere identificato come il nucleo fondante della moderna economia politica, che può essere fatta risalire almeno agli scritti di Bernard Mandeville, James Steuart e Adam Smith, ognuno dei quali teorizzava che il lavoro dei singoli fatto per conseguire i personali obiettivi economici finisse per contribuire naturalmente al bene comune.
Philanthrocapitalism di Bishop e Green presenta appena due riferimenti veloci all'opera di Smith, evitando di approfondire la questione. Con l'obiettivo forse di promuovere l'originalità delle proprie tesi i due glissano sulle similitudini tra le loro teorie e l'idea della mano invisibile formulata da Smith, secondo cui «perseguendo il proprio interesse [l'individuo] finisca per fare anche quello della società nonostante non parta con quell'intenzione».
Felix Salmon, ex reporter dell'agenzia Reuters, si è focalizzato su questa particolare amnesia storica. Nel criticare la pretesa novità delle nozioni alla base del filantrocapitalismo, Salmon afferma in particolare che «la presa di coscienza che le dinamiche di business abbiano la capacità di creare così come di distruggere valore sociale rientra in quella cosa che viene chiamata 'economia' e va fatta risalire almeno ad Adam Smith. Non c'è nulla di nuovo in tutto ciò e c'è ancor di meno di nuovo negli economisti che fanno leva su tali concetti per alleviare in qualche modo il senso di colpa dei ricchi».
Il filosofo Slavoj Zizek ha anche messo in luce lo strano dèjà vu che permea la retorica degli entusiasti del filantrocapitalismo, arrivando a definire le loro massime ricorrenti come una «versione trasposta nella postmodernità dell'idea della mano invisibile di Adam Smith: il mercato e la responsabilità sociale non come opposti in contrapposizione tra loro e che possono anzi essere coniugati con mutuo beneficio... la loro finalità non viene dunque presentata come fare soldi, ma cambiare il mondo, e guadagnare ancora più denaro in tutto ciò diventa quasi un effetto secondario».
Sia Salmon che Èizek fanno annotazione brillanti e convincenti. Però non si può negare che ci siano effettivamente "un paio" di novità apportate dal filantrocapitalismo. Una è la scala su cui opera, l'altra è la chiarezza con cui si espone. Parlando della scala d'azione, senza addentrarsi tanto nei freddi numeri che comunque da soli non spiegano tutto, appare comunque evidente come il fenomeno sia percepito in forte ascesa a livello globale. Quasi la metà delle 85.000 fondazioni private nei soli Stati Uniti d'America sono nate negli ultimi quindici anni. In media ne nascono circa 5000 all'anno.
Gli esperti divergono tra loro quando si afferma che questo fiorire di fondazioni private corrisponda concretamente a un significativo incremento del volume di investimenti nell'ambito della beneficenza rispetto ai decenni passati.
Ray Madoff, professore di Diritto al Boston College, fa notare come all'interno degli Stati Uniti il totale delle donazioni caritatevoli sia rimasto stabile a più o meno il 2% del prodotto interno lordo fin dagli anni Settanta del Novecento e i contributi dei privati in questi decenni non abbiano subito grosse variazioni, restando sempre a circa il 2% del reddito complessivo.
Allargando lo sguardo oltre i confini statunitensi diventa più facile sostenere che la filantropia globale sia in forte crescita. David Moore e Douglas Rutzen del Centro internazionale per il diritto no profit asseriscono che la beneficenza su scala globale sia cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni, una crescita che «è corrisposta all'incremento della ricchezza privata in Brasile, India, Cina e altri Paesi»
Questo incremento della filantropia su scala mondiale sarebbe collegato a doppio filo con un aumento della concentrazione della ricchezza in mano ai privati, circostanza che ha favorito la possibilità di dare in beneficenza somme da capogiro.
La ricchezza mondiale ovviamente ha avuto dalla sua anche la "bella" crisi finanziaria nel 2007 e negli anni seguenti, quando la stabilità dei mercati finanziari mondiali cominciò a vedere concretamente la possibilità di una catastrofe senza precedenti. Ebbene, negli Stati Uniti il volume delle entrate dell'1% più ricco della popolazione è cresciuto di un clamoroso 31% negli anni che vanno dal 2009 al 2012, mentre per il resto del Paese si parla di un misero 0,4%. In gran parte, coloro che fanno parte di di quell'1% hanno riutilizzato le proprie nuove fortune per rimpinguare le casse delle fondazioni di beneficenza da loro stessi create.
Ma a quale scopo tutto questo?
Quel che è più rimarchevole riguardo al crescente numero di fondazioni negli ultimi due decenni è che di fatto non hanno avuto alcun risultato nell'attenuazione delle disuguaglianze economiche. Che cosa dedurre dal dato di fatto che la filantropia e le disuguaglianze siano entrambi fenomeni in grossa espansione e che sembrano addirittura crescere parallelamente? Si può dire che la filantropia fa parte di un sistema in cui il ricco diventa più ricco e il povero si impoverisce ulteriormente?
È difficile fare con certezza assoluta asserzioni su un rapporto di causalità tra i due fatti. Ci sono però varie ragioni che potrebbero effettivamente spiegare come l'aumento delle opere di carità sia complementare a quello delle disuguaglianze e alla crescita della povertà generale.
Una di queste è che le donazioni caritatevoli finiscono per incidere negativamente sulle entrate delle tasse che potrebbero a loro volta essere impiegate per politiche distributive di aiuto sociale alle fasce più indigenti.
Il secondo è che in realtà la gran parte delle donazioni di beneficenza non sono indirizzate al sostentamento economico della parte più povera della popolazione. Lo studio annuale del report Giving USA per l'anno 2012 ha riportato che solo il 7% del totale della cifra data alla carità nell'anno precedente in tutto il Paese è stato destinato a progetti definiti «a vantaggio dell'interesse pubblico», in contrasto con somme ben più ingenti investite per fini religiosi e culturali.
Un report a cura del Comitato nazionale per la beneficenza attiva ha stabilito che il 55% delle donazioni destinate a enti nel settore dell'arte negli Stati Uniti sono dirette a realtà che hanno già budget superiori ai 5 milioni di dollari e che costituiscono meno del 2% delle oltre 100.000 associazioni artistiche e culturali no profit operanti nel Paese. Il pubblico di riferimento per questi fortunati enti tende ad appartenere all'alta borghesia Wasp.
Un altro dubbio è che la beneficenza venga in ultima analisi sfruttata per sfuggire alle richieste di tassazioni più elevate e proteggere ed espandere realtà economiche forti piuttosto che implementare vere politiche di giustizia sociale: essa spesso viene usata come grimaldello per aprire mercati per multinazionali con sede in Europa o negli Usa che si associano a gruppi come la Fondazione Gates per raggiungere nuovi consumatori.
Donare di più diventa in questo senso un modo per avere di più e finisce per contribuire ad accentrare la ricchezza a vantaggio di un gruppo ristrettissimo di magnati che al tempo stesso si garantiscono un'influenza sempre maggiore sulle prospettive decisionali di organizzazioni come l'OMS e la FAO [Food and Agriculture Organization, Organizzazione per il cibo e l'agricoltura] delle Nazioni Unite.
I filantropi stessi sono spesso i primi ad ammettere che le loro opere sono indirizzate a preservare lo status quo piuttosto che a redistribuire le risorse nella società.
Il più sincero a questo proposito è probabilmente Carlos Slim, che ha riassunto il proprio impegno benefico con la seguente frase: «Il benessere va trattato come un frutteto. Devi condividerne i frutti, non le piante che li generano».
La sua sincerità ha il pregio di mettere in luce un altro aspetto distintivo dei nuovi filantropi: la loro schiettezza sui vantaggi personali che le donazioni caritatevoli garantiscono loro.
In effetti, qualcosa di veramente inedito al giorno d'oggi è proprio il modo conclamato in cui i grandi benefattori non solo ammettono, ma addirittura sbandierano la beneficenza come mezzo utile per difendere le posizioni acquisite. Fenomeno questo che li distingue dai loro predecessori.