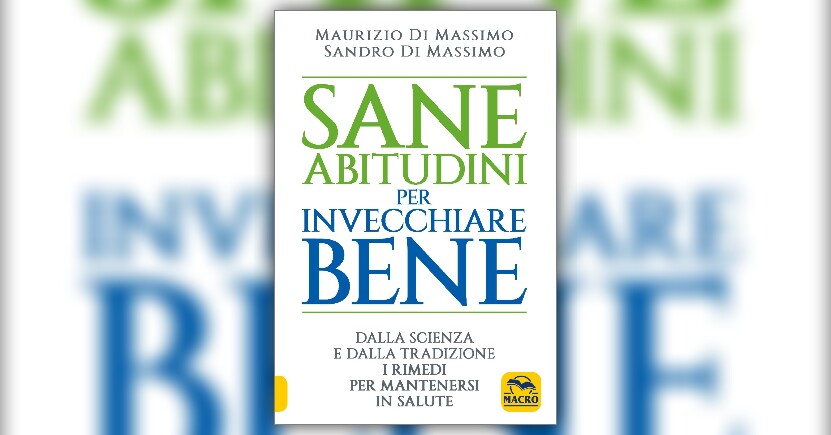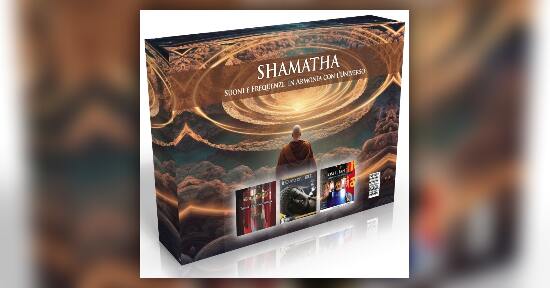Il tempo non è uguale per tutti
Pubblicato
4 anni fa
Leggi un estratto da "Sane Abitudini per Invecchiare Bene" di Maurizio e Sandro Di Massimo
Nella percezione comune, lo scorrere del tempo, inteso come un flusso continuo di eventi che legano passato, presente e futuro, appare scontato e ineluttabile. Esistono anche dei "misuratori temporali" di origine naturale, sintonizzati con il cosmo, che regolano la funzionalità del corpo (bioritmi) in relazione ai fenomeni astronomici, meteorologici e climatici.
In questi termini, tutta la materia vivente è permeata da un'intricata rete di meccanismi che stimolano o inibiscono le funzioni indispensabili alla vita. Basti pensare ai ritmi che regolano l'attività respiratoria, cardiocircolatoria, cerebrale, riproduttiva e ormonale.
Nel lessico quotidiano esiste una vasta terminologia per designare scansioni temporali precise, utili a regolamentare le attività umane. Alla stessa maniera, la durata dell'esistenza terrena è associata all'idea newtoniana di spazio e velocità: un soggetto si muove da una dimensione iniziale conosciuta (nascita) verso una meta finale (morte).
In un lontano passato però le cose erano percepite in maniera diversa. Per Platone, ad esempio, il tempo era «l'immagine mobile dell'eternità» e sant'Agostino nelle sue riflessioni si chiedeva: «Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più».
Anche la scienza moderna, nelle sue posizioni estreme (teoria della relatività generale e fisica quantistica), rimette in discussione l'oggettività di questa misteriosa dimensione, asserendo che non esiste un "presente uguale per tutti".
Infatti, quando s'incontrano delle realtà dalle peculiarità inusuali, come l'universo cosmico o il mondo microscopico degli atomi, l'importanza del ruolo svolto da un osservatore in un sistema spazio-tempo, volutamente omessa dalla fisica classica, ritorna con tutte le sue accattivanti implicazioni scientifiche, filosofiche ed epistemologiche.
In questa nuova visione, spazio e tempo non sono parametri assoluti ma relativi, essendo condizionati da vari fattori come la velocità con cui un soggetto si muove e dalla capacità della coscienza di interagire con la materia.
Albert Einstein, con la sua teoria della relatività, ha dimostrato che quando ci si muove nell'ordine della velocità della luce le indicazioni temporali sono condizionate dalla posizione dell'osservatore, infatti, il fluire del tempo è inversamente proporzionale alla velocità con cui si viaggia.
L'esempio concettuale più famoso che illustra questa teoria è quello del cosiddetto "paradosso dei due gemelli", secondo il quale un gemello che intraprende un viaggio nello spazio su una navicella a velocità prossima a quella della luce, una volta ritornato sulla Terra scopre che il fratello è diventato molto più vecchio di lui.
Secondo la teoria di Einstein la forza di gravità dei corpi dotati di massa, possiede la proprietà di curvare lo spazio ed essendo quest'ultimo inseparabile dal tempo, anche il tempo subisce l'influenza della materia, procedendo con ritmi diversi rispetto a luoghi differenti dell'Universo. Ad esempio, il fatto che i pianeti del sistema solare descrivano orbite ellittiche non è legato a un equilibrio di spinte attrattive, ma piuttosto alla forza del campo gravitazionale del Sole che riesce a incurvare lo spazio.
Quando il tempo perde la sua oggettività, diventa un'entità astratta, la cui natura muta in relazione alla complessità di numerose variabili nascoste.
Gli antichi Greci identificavano il tempo con Oceano, il mitico fiume che avvolgeva la Terra come un grande serpente intento a mangiarsi la coda (uroboros). Lo stesso simbolo circolare accompagnava il dio Aion che, oltre a impersonare il fluire dell'esistenza, donava energia a tutti gli esseri viventi, regolandone il destino e la durata della vita.
Nell'antica tradizione cinese l'esperienza temporale era affiancata alla ruota della causalità, diventando uno strumento per legare la realtà materiale a quella psichica, e viceversa (il fenomeno della sincronicità rende concreto ciò che esiste in forma potenziale).
In India, il tempo assumeva le sembianze di Shiva Nataraja che attraverso la sua danza avvolgeva l'universo in un cerchio di fuoco, scandendo, con il ritmo del tamburo, i cicli cosmici della creazione e della distruzione.
Anche i concetti di "reincarnazione" e di "karma" (legati alla prefigurazione religiosa del ciclo di rinascite) riflettono questa visione, poiché sono legati a eventi terreni e spirituali mossi da una ritmicità indissolubile.
In molte antiche tradizioni il tempo simboleggiava l'anima del Mondo, da cui prendevano forma l'acqua, il fuoco e l'aria. La sua natura rifletteva la ciclicità dei mutamenti, come il susseguirsi della veglia e del sonno, della fame e della sazietà, dei mutamenti biologici del corpo, dei periodi riproduttivi e, in particolare, del ritmo del giorno e della notte, delle fasi lunari e di quello delle stagioni.
A questa concezione circolare del tempo si contrappone quella lineare, tipica della tradizione cristiana, dove il cammino dell'umanità è segnato da una lunga linea retta che attraverso la Bibbia, procede a senso unico dal peccato originale alla redenzione finale. Per il cristiano la vita si dispiega come una lunga sequenza di eventi unici e irreversibili, legati alla figura di Gesù, al simbolo della Croce e al giudizio universale.
I primi strumenti che l'uomo ha costruito per misurare il tempo si fondano su questa idea di flusso continuo. I Caldei e gli Egizi possedevano orologi basati sullo scorrere dell'acqua in appositi contenitori, contrassegnati da indicatori graduati. In seguito furono utilizzati orologi tarati sul tempo necessario a bruciare candele di diversa lunghezza o far scorrere della sabbia all'interno di due recipienti sovrapposti (clessidre).
In seguito furono inventati lo gnomone e la meridiana, entrambi utili per seguire nell'arco della giornata lo spostamento del sole; seguirono poi gli orologi meccanici a carica fino ad arrivare a quelli elettronici e atomici (che scandiscono il tempo sfruttando la frequenza di risonanza di un atomo).
La veloce accelerazione subita dai mezzi di trasporto e dalle tecnologie di comunicazione ha contribuito a modificare radicalmente le nostre esperienze di spazio e di movimento. Nella società moderna la misurazione del tempo e le questioni del "vivere" si fondono in un complesso di regole e impegni che condizionano profondamente i nostri modelli comportamentali.
Nella dimensione personale, il tempo rimane un'entità instabile, sensibile a numerosi fattori di natura psicologica, legati soprattutto all'età, alle aspettative di vita e al grado di consapevolezza delle nostre azioni.
Le persone anziane sono abituate a stimare la lunghezza della vita da un punto di vista retrospettivo, orientato su un passato già definito, al contrario dei giovani più inclini a prospettive future.
Prima dei 2 anni viviamo un "senso eterno" del presente, poi in maniera progressiva prendiamo atto che esiste un passato e un futuro, fino a sperimentare, intorno ai 16 anni, quello che viene definito il "comune senso del tempo", condizionato da orari e impegni sociali.
La percezione del suo trascorrere aumenta di pari passo al grado di attenzione e di partecipazione; mentre procede lentamente in presenza di un disagio psicofisico, come noia, stanchezza, paura, dolore, inquietudine o ansia.
Distorsioni temporali sono sperimentate anche nel corso di forti emozioni, negli stati meditativi, come conseguenza dell'uso di droghe e addirittura in rapporto al metabolismo e alla temperatura corporea. Ad esempio, riguardo a questi due ultimi parametri, abbiamo l'impressione che il tempo scorra più veloce il mattino e la sera, quando i valori della temperatura e del metabolismo si abbassano in maniera fisiologica; una sensazione contraria è vissuta durante il pomeriggio fino alle prime ore della sera. Non a caso con l'invecchiamento, sia la temperatura corporea sia il metabolismo tendono ad abbassarsi in maniera naturale.
Ma le sorprese non finiscono qui: alcune ricerche nell'ambito delle neuroscienze tendono ad avvalorare l'ipotesi secondo cui più la nostra mente è aperta al mondo esterno e alla miriade di informazioni che da esso provengono, più lentamente percepiamo il trascorrere del tempo. Ecco perché i bambini, dotati naturalmente di un'elevata percettibilità nei confronti del mondo, sembrano disporre di una maggiore quantità di tempo.
Durante la fase di invecchiamento attraversiamo un periodo di transizione, in cui da osservatori, inclusi come parte integrante del sistema, non ci accorgiamo del processo del divenire che è in atto.
Quando si guarda a se stessi, non è possibile isolare la propria vita e la propria vecchiaia, ponendosi all'esterno nel tentativo di renderla oggettiva (non esiste un osservatore esterno come nella scienza classica).
Termini comuni come "abitudine", "routine", "pendolarismo", sono propri di un quotidiano segnato da ritmi che richiamano, inequivocabilmente, l'idea di un movimento circolare.
Gustav Jung, rapportando lo studio delle tradizioni orientali e dell'antica alchimia al lavoro di analisi dei sogni dei suoi pazienti, ha elaborato due concezioni psicologiche particolarmente innovative e brillanti: la teoria dell'inconscio collettivo e quella della sincronicità, dove la memoria e il tempo giocano un ruolo chiave, anche se con significati e valori in antitesi ai modelli razionali dettati dal senso comune. Ad esempio, nella dimensione profonda della psiche, la rotondità dei nostri orologi richiama l'archetipo della perfezione e dell'immortalità, e acquista la funzione di un vero e proprio mandala, utile a superare i limiti della coscienza.
In questi termini, l'inconscio si apre a un territorio indifferenziato, privo di definizioni e confini, dove il tempo assume le caratteristiche di una dimensione reversibile. In altri termini, la manifestazione della realtà e l'esperienza temporale sono il frutto del contenuto della nostra coscienza e come tali sono legati a un evento psicologico soggettivo. Paradossalmente quando la mente è assente sia la materia sia il tempo semplicemente scompaiono o perdono di significato.
Quando si affronta il tema del tempo, i confini della ragione e dell'immaginazione si dilatano e si mescolano tra loro. Anche se è opinione comune pensare allo scorrere del tempo come una progressione ordinata di eventi che si muovono lungo una linea retta, dal passato verso il futuro, nello dimensione personale questo fenomeno rimane un'entità instabile, soggettiva e quindi sensibile a numerose variabili.
Il grado di consapevolezza, le condizioni emotive, l'età, lo stato di salute, lo temperatura del corpo e dell'ambiente sono alcuni dei fattori più importanti che influiscono sulla percezione della durata degli eventi che si susseguono giornalmente. Del resto, è la stessa fisica moderna a mettere in discussione il "concetto di oggettività" (cardine fondamentale su cui poggia il metodo scientifico) svelando un "presente" di natura soggettiva che si dilata o si restringe secondo un sistema spazio-tempo non assoluto, ma relativo.
In questa nuova visione, spazio e tempo non sono parametri assoluti ma relativi, essendo condizionati da vari fattori come la velocità con cui un soggetto si muove e la capacità della coscienza di interagire con la materia.
Per continuare a leggere, acquista il libro: