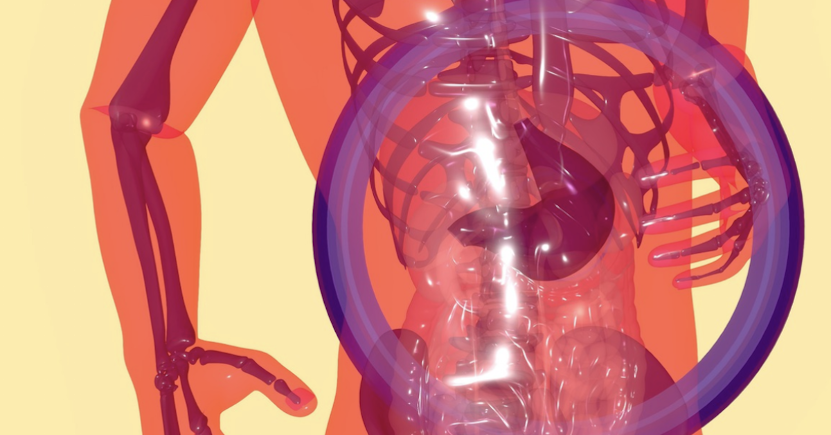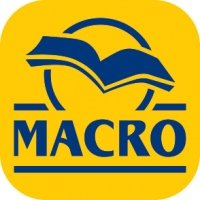Il microbiota intestinale, un amico importante
Pubblicato
2 anni fa
Scopri il ruolo fondamentale del microbiota intestinale in tutti i sistemi del nostro corpo
È assolutamente chiaro che il mondo in cui viviamo sia dominato dai batteri. I microbi abitano questo pianeta da centinaia di milioni di anni e quindi, da molto più tempo rispetto agli esseri umani.
Non è mai esistito un tempo in cui il nostro corpo non sia stato abitato dai microbi e non ne sia stato influenzato. Attraverso studi compiuti con tecnologie di sequenziamento sul microbioma, si è potuto dimostrare che le stime iniziali che venivano riportate sulla numerosità della popolazione microbiotica non fossero corrette (inizialmente si pensava che i batteri intestinali fossero dieci volte di più rispetto alle cellule umane), pertanto il rapporto cellule/microrganismi è stato recentemente ribassato da 10:1 a 1,3:1.
Sebbene dunque questo numero sia stato considerevolmente ridotto, il microbiota rimane un’unità costituita da una cifra notevole di elementi attivi. Questi calcoli lasciano ancor più sorpresi quando vengono rapportati alla genetica: il 99% dei geni presenti nel nostro organismo sono microbici, infatti i batteri del microbiota esprimono oltre 10 milioni di geni, contro i 23.000 del genoma umano.
Poiché ci siamo evoluti insieme al microbiota, sappiamo che esso svolge un ruolo chiave nella programmazione anche epigenetica di tutti gli altri sistemi corporei.
Stai per leggere un estratto del libro:
Come lavora il microbioma
È molto interessante considerare che il nostro genoma ereditato è sostanzialmente stabile per tutta la vita dell’ospite, mentre il microbioma può essere molto dinamico e reattivo in relazione agli stimoli esterni e avere immense variazioni nel corso della nostra vita. Tutto questo, naturalmente, può avere anche importantissime implicazioni terapeutiche. Ogni angolo o anfratto del nostro corpo possiede un proprio microbiota.
Tuttavia, i principali distretti dell’organismo colonizzati da microbi sono: la pelle, le vie aeree, il tratto urogenitale, gli occhi, il tratto gastrointestinale, la bocca e i polmoni. L’intrigante complessità di questa comunità è rappresentata dal fatto che l’intestino ospita, come abbiamo detto, una popolazione estremamente variegata di microrganismi inclusi lieviti, Archaea, parassiti come elminti, virus e protozoi, ma indubbiamente la popolazione batterica è attualmente la più rappresentata, studiata e identificata.
Ancora oggi moltissime persone si stupiscono di scoprire che nel loro intestino vivono ad esempio gli ossiuri e troppo spesso, anziché domandarsi il motivo di un loro aumento di numero (in questo caso una parassitosi che corrisponde in tutto e per tutto a una disbiosi) e agire sull’infiammazione di base (sul terreno, quindi), preferiscono utilizzare farmaci vermifughi che inevitabilmente altereranno in maniera significativa l’ecosistema intestinale.
Le differenze fra persona e persona
Effettivamente siamo solo all’inizio della comprensione del ruolo e delle implicazioni che il microbiota ha nei confronti della nostra salute. Quindi, necessariamente, questo libro non potrà che avere un ruolo di transizione in questo rapido flusso di mutazione delle conoscenze.
Oltretutto, è importante evidenziare come il microbiota dell’intestino vari moltissimo da individuo a individuo, mentre le variazioni non sarebbero così significative (in condizioni di salute) durante la vita di una persona. Ciò che sembra essere fondamentale è il mantenimento dell’omeostasi nella popolazione microbica per garantire lo stato di salute oppure condizionare quello di malattia, come quella riscontrata nel cancro del colon-retto.
Nonostante le sfide poste da questa ampia variabilità interindividuale, alcuni centri di ricerca hanno tentato di classificare le colonie del microbiota intestinale umano in diversi enterotipi. Tale sistema di classificazione rimane alquanto controverso e semplicistico, sebbene siano stati proposti tre distinti enterotipi, ciascuno dei quali caratterizzato da livelli relativamente alti di un singolo genere microbico: Bacteroides, Prevotella o Ruminococcus.
Questi enterotipi però sembrano avere discreta importanza quando si consideri ad esempio l’enterotipo Bacteroides con diete ad alto contenuto di grassi o ad alto contenuto proteico oppure l’enterotipo Prevotella con diete ad alto contenuto di carboidrati e relative patologie. Si spera che gli studi futuri possano trarre vantaggio dall’utilizzo di tecnologie moderne, come la metagenomica, consentendo stime più affidabili della composizione e diversità del nostro microbiota, ma anche fornire informazioni preziose circa le potenziali funzioni e interazioni del microbiota sul nostro organismo e, in particolare, sull’asse cervello-intestino.
Infine, va detto che l’analisi metabolomica è diventata sempre più importante e sempre più informativa; ad esempio è stato visto un effetto causale del microbiota sulla produzione di butirrato associato a una migliore risposta all’insulina dopo un test di tolleranza al glucosio orale, così come l’alterazione della produzione o dell’assorbimento di propionato sarebbe correlato a un aumento del rischio di diabete di tipo II. Si può solo sperare che studi come questi si propaghino rapidamente visto il loro immenso potenziale per definire terapie alternative per le malattie.
Cervello-intestino e microbiota
Negli ultimi decenni, gli ambiti della microbiologia e delle neuroscienze sono diventati sempre più intrecciati tra loro. Sebbene il concetto di asse cervello-intestino-microbiota sia relativamente recente, è diventato sempre più chiaro come il microbiota residente possa esercitare una notevole influenza sul comportamento dell’ospite.
Il tratto gastroenterico esercita una profonda influenza sulle funzioni cerebrali e viceversa. La comunicazione bidirezionale lungo l’asse cervello-intestino è fondamentale nel contesto della sinergia tra microbiota e ospite e per la modulazione delle risposte. In passato, la maggior parte degli studi si sono interessati alla comunicazione intestino-cervello e si sono concentrati sulla funzione digestiva e sulla sazietà, ma la ricerca più recente si è concentrata ormai sempre di più sugli effetti cognitivi e psicologici della relazione tra intestino e cervello.
Attraverso queste ricerche, ora possiamo comprendere alcune conseguenze fisio-patologiche che un rapporto alterato tra intestino e cervello può causare; per esempio l’infiammazione cronica di basso grado, l’infiammazione intestinale correlata a disturbi sistemici, le risposte alterate allo stress acuto e cronico, così come alcuni stati comportamentali alterati.
È così che l’asse cervello-intestino diventa un obiettivo molto interessante per lo sviluppo di nuove terapie per un numero sempre maggiore di disturbi relativi alla salute mentale e alle funzioni cognitive, ai disturbi del comportamento alimentare, all’obesità e ai disturbi gastrointestinali come le malattie infiammatorie o funzionali intestinali comunemente note con gli acronimi IBD (malattia infiammatoria inte-stinale) e IBS (sindrome dell’intestino irritabile).
In che modo potrà essere possibile questo target terapeutico? Prima di tutto individuando un piano alimentare adatto per ogni singolo soggetto e successivamente andando ad agire direttamente a livello dell’asse cervello-intestino, ad esempio at-traverso la somministrazione di specifici ceppi probiotici attivi su di esso, chiamati appunto psicobiotici (quindi, interventi mirati sul microbiota che supportino una buona salute mentale).
Se vuoi approfondire ogni aspetto dell'asse cervello-intestino-microbioma ti consigliamo la lettura del libro