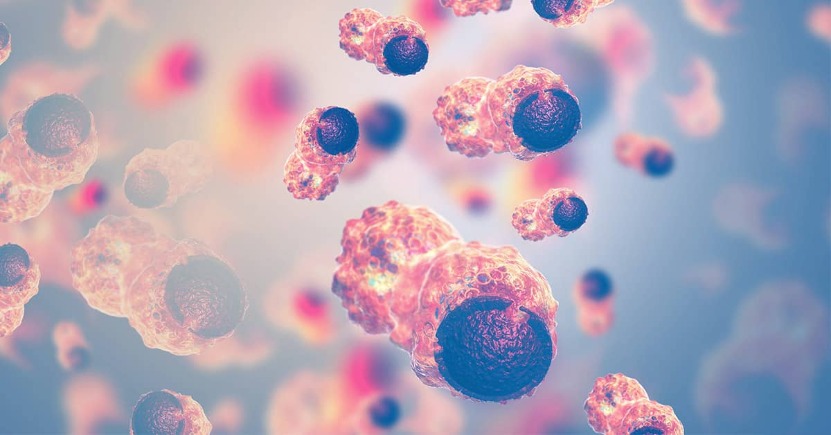I tumori sono cannibali?
Pubblicato
3 anni fa
Lo sapevi che le cellule tumorali, come le amebe, si cibano di altre cellule, anche di quelle che dovrebbero difenderci dai tumori? Grazie a questa nuova scoperta però si apre la strada a un nuovo approccio integrato. Scopri quale!
La parola cannibalismo (dallo spagnolo canìbal, in riferimento alla pratica in uso tra i Caribe), anche chiamata antropofagia, si riferisce all'atto o alla pratica di umani che si cibano di altri umani.
In zoologia, il termine cannibalismo viene esteso a ogni specie che abbia l'abitudine di cibarsi dei propri simili.
Mi viene in mente quando, con grande fatica, mantenevo un acquario pieno di pesci dì ogni specie e vedevo continuamente madri cibarsi dei propri figli, per cui i pesci neonati venivano fatti crescere in una zona nido, lontani dalle madri.
Il cannibalismo in natura è considerato una forma di "interazione ecologica" condivisa da almeno 1500 specie, numero che è da considerarsi una grossolana sottostima.
È utile sottolineare che, nonostante il cannibalismo possa avere dei caratteri distintivi da specie a specie, la forma più comune di questo fenomeno è quello legato alle differenze di stazza (size structured cannibalism), per cui gli individui più grandi mangiano quelli più piccoli (Elgar et al., 1992).
Il cannibalismo è praticato anche dai microrganismi, alcuni dei quali lo utilizzano per nutrirsi. Questo è il caso dei batteri formanti spore, come il Bacillus subtilis, che usa sia le spore che i suoi "familiari" per nutrirsi in caso di mancanza di altro nutrimento (Gonzalez-Pastor et al., 2003); ma anche parassiti come il Dictyostelium discoideum, che si ciba di altri batteri o comunque di altre cellule attraverso la fagocitosi (Chi et al., 1959).
Stai leggendo un estratto del libro:
C'è chi mangia per difendersi: i macrofagi al servizio del sistema immunitario
L'attività cannibalica delle cellule tumorali è una storia antica che è stata trascurata per più di un secolo e solo da poco riconsiderata. Le prime osservazioni istologiche – che indicavano la presenza di cellule dentro ad altre cellule all'interno dei tumori – risalgono a circa centoventi anni fa (Steinhaus, 1891; Stroebe, 1892).
Cannibalismo o Autofagia?
Nella nostra specie il cannibalismo vero e proprio è stato descritto unicamente nei tumori (DeSimone et ai., 1980; Fujii et al., 1986; Kojima et ai., 1998; Kumar et 2001; Caruso et ai., 2002; Abodief et ai., 2006; Brouwer et ai., 1984).
Quello che invece si sa avvenire in un organismo umano normale, in condizioni di scarso apporto di nutrienti, viene chiamato "autofagia" (Klionsky et ai., 2004); per esempio si sa che il calo ponderale dei neonati, quando quindi vengono staccati dal cordone ombelicale, è causato dal fatto che si cibano di riserve accumulate durante il periodo precedente alla nascita, tramite un processo autofagico.
Cioè i neonati per sopravvivere si cibano di se stessi, fino all'inizio dell'alimentazione tramite il latte materno.
Per più di un secolo il cannibalismo è stato considerato una curiosità da istopatologi. Infatti, inizialmente, la definizione di cannibalismo tumorale era esclusivamente citopatologica o istologica.
Si parlava di cannibalismo quando nei tessuti si ritrovavano cellule che contenevano altre cellule più piccole, per lo più contenute in un vacuolo che spingeva il nucleo della cellula cannibale verso la periferia, dandogli una forma a semiluna (crescent shaped).
È curioso come gli istopatologi si siano sbizzarriti nel dare nomi suggestivi a queste cellule. Quella che da sempre mi è piaciuta più delle altre è stata "cellule ad occhio di uccello" (birds eye cells).
Quando mi occupavo prevalentemente di apparato digerente, per chi guardava nei vetrini, una delle formazioni cellulari sinonimo di malignità era rappresentata dalle "cellule ad anello con castone" (signed ring cells) che, pur apparentemente non contenendo altre cellule ma muco, avevano una forma molto simile alle cellule cannibali, con il nucleo schiacciato da una parte (castone) e il citoplasma ridotto a una rima sottile e circolare (anello), a causa del muco accumulato.
Oggi l'insieme di questi fenomeni si definisce cellula-in-cellula (celi-in-celi) e li raggruppa veramente tutti: cannibalismo cellulare omotipico, fagocitosi, entosi, emperipolesi ed emperitosi; perché in tutti, indipendentemente dal meccanismo che ne è la causa, si osserva la presenza di una cellula dentro un'altra cellula (Fais et al., 2018).
Il mio passato da citopatologo mi ha spinto a capirne di più: continuavo a vedere, nelle preparazioni di cellule tumorali che usavamo quotidianamente nei nostri esperimenti, enormi cellule contenenti a loro volta una o più cellule, che spesso sembravano vive.
.jpeg)
Per i miei studi in questo ambito sono partito da lontano perché ho cominciato studiando la storia di un premio Nobel, il quale con le sue scoperte aveva gettato le fondamenta della moderna immunologia. Si chiamava Il'ja Il'ic Mecnikov — meglio noto come Élie Metchnikoff — che ricevette il premio Nobel per la medicina insieme a Paul Ehrlich nel 1908. A quei tempi la fagocitosi era considerata una funzione caratteristica e fondamentale dei principali microrganismi unicellulari, generalmente chiamati amebe, la cui capacità di nutrirsi di altri microrganismi era conosciuta sin dai primi studi sulle malattie infettive, basati quasi esclusivamente sull'uso del microscopi.
Si sapeva infatti che le amebe ingeriscono, uccidono e digeriscono altri microrganismi nell'intento di trarre da essi nutrimento (Tauber, 2003).
Mecnikov iniziò i suoi studi sulle amebe, ma spostò in seguito il suo interesse sugli organismi multicellulari. In questi ultimi egli notò l'esistenza di cellule mobili la cui attività fagocitica veniva impiegata allo scopo di difendersi nei confronti degli ‘'agenti esterni".
Mecnikov chiamò inizialmente queste cellule "fagocitelle".
Questi studi portarono a un cambiamento radicale nella visione della fagocitosi, in maniera quasi paradigmatica, per cui si passò dal considerare la fagocitosi un modo di "mangiare per nutrirsi" al moderno concetto di "mangiare per difendersi", e quelle cellule furono chiamati "macrofagi", cellule immunitarie che possiamo definire gli spazzini del corpo umano.
Successivamente si è scoperto che, oltre a fare attività di "scavenging" — cioè eliminare microrganismi e in genere detriti cellulari di ogni tipo — i macrofagi assimilano, processano e presentano antigeni al sistema immunitario giocando, quindi, un ruolo cruciale nel processo di adattamento della risposta immunitaria nei confronti degli agenti esterni.
C'è chi mangia per nutrirsi: le cellule tumorali
Quindi, mentre la funzione di fagocitare per difendersi è da considerarsi una funzione evoluta delle nostre cellule, quella di fagocitare per nutrirsi è da considerarsi invece una funzione primitiva, qualcosa di ancestrale (Lozupone et al., 2015), che non dovrebbe appartenere a organismi complessi, come il corpo umano.
Quello che mi colpì subito fu che i risultati del nostro lavoro dimostravano che le cellule tumorali fagocitano per mangiare, in maniera del tutto analoga alle amebe, e lo fanno nei confronti di qualsiasi cellula capiti nelle loro vicinanze (Lugini et al., 2006].
Era ancora più interessante notare come il cannibalismo tumorale fosse caratteristica peculiare di cellule derivanti da lesioni metastatiche, mentre era quasi assente in cellule derivanti da tumori primari. Questo fatto ci suggeriva che il cannibalismo tumorale potesse rappresentare un segno di riconoscimento per le cellule metastatiche o, comunque, per cellule molto maligne o con un basso grado di differenziamento.
A sottolineare l'importanza di questa scoperta, si è visto che a differenza dei macrofagi, che fagocitano solo cellule morte o detriti (Lugini et al., 2003), le cellule metastatiche endocitano e digeriscono indifferentemente sia materiale amorfo che cellule apoptotiche, cellule sane e perfettamente funzionanti, incluse quelle che dovrebbero rappresentare una delle nostre difese maggiori contro i tumori, i cosiddetti linfociti T anzi-tumorali (Lugini et al., 2006).
A supporto di questa considerazione, nello stesso lavoro abbiamo dimostrato che, se si aggiungono alle colture di cellule tumorali altre cellule, si osserva che l'attività cannibalica continua indisturbata e le cellule tumorali non danno segni di sofferenza; se invece si aggiunge materiale privo di qualsiasi nutrimento, come le biglie di latex, le cellule tumorali si ingolfano delle biglie senza poterle digerire e muoiono (Lugini et al., 2006).
Questa scoperta è sembrata di grande importanza anche per la messa a punto di nuove strategie anti-tumorali basate sulla somministrazione di materiale indigeribile ai tumori, che con voracità endocitano tutto quello che incontrano.
Tumori come amebe
Il cannibalismo tumorale è da considerarsi un fattore di sopravvivenza di grande importanza e, insieme all'acidità (Fais, 2019), un fattore di isolamento dal resto dell'organismo. Infatti aggredendo i linfociti anti-tumorali, le cellule di cancro non solo si nutrono, ma si proteggono dalla risposta immune nei loro confronti [Lugini et al., 2006, Fais et al., 2007; Fais et al., 2012 ].
Ma l'aspetto più interessante di questa scoperta è la correlazione fra la malignità tumorale e una sorta di regressione verso una vita più semplice (ancestrale), simile a quella delle amebe, il cui scopo è sopravvivere e propagarsi in un ambiente ostile.
L'unico momento della vita di un individuo che assomiglia al comportamento delle amebe è lo stato embrionale in cui, al contrario di quello che succede nell'organismo formato, le cellule sono in lotta le une contro le altre per pura necessità di sopravvivenza.
Qualcuno sostiene che anche la determinazione del sesso derivi da questa lotta fratricida iniziale.
Da qui l'idea che il tumore maligno possa rappresentare un momento di regressione verso uno stato più ancestrale, per esempio lo stato embrionale. Ed è sicuro che ognuno di noi ha nel proprio corpo un residuo di vita embrionale, che nelle intenzioni dovrebbe rappresentare un reservoir di cellule molto immature e quindi con un grande potenziale di rimpiazzare cellule e tessuti di ogni tipo, ma purtroppo con un'elevata possibilità di trasformazione e moltiplicazione sotto forma di tumore.
Sta di fatto che questa scoperta ha portato all'individuazione di una proteina, ovviamente legata a un gene, che le amebe e le cellule tumorali hanno in comune, TM9SF4 [Fais et al., 2012; Lozupone et al., 2009], la quale è correlata alla capacità di cannibalizzare altre cellule, ma non solo [Fais et al., 2012].
Alla luce di questi risultati abbiamo chiamato questa proteina, e il gene correlato, "Amor Cannibalism Associateti Protein 1 (TUCAP-1)".
Più di recente, la stessa linea di ricerca ha dimostrato che TM9SF4/TUCAP1, ormai considerata una nuova oncoproteina, ha un ruolo chiave nel far funzionare una delle pompe protoniche associate all'acidificazione dell'ambiente extracellulare chiamata anche ATPasi vacuolare, (V-ATP-asi), [Lozupone et al., 2015).
La V-ATP-asi è una pompa protonica altamente attiva nei tumori maligni e abbiamo dimostrato che è un bersaglio, anche se non completamente specifico, degli inibitori di pompa protonica (PPI) (Luciani et al., 2004; Fais et al., 2007].
Nello stesso studio del 2015 abbiamo dimostrato che, inibendo molecolarmente la TM9SF4/TUCAP1, si riduce notevolmente sia la capacità delle cellule tumorali di invadere i tessuti sani limitrofi, sia la capacità di incrementare la sensibilità ai farmaci anti-tumorali.
Inoltre, inibendo la sintesi tumorale di TM-9SF4/TUCAP1 si agisce direttamente sul pH tumorale con aumento del pH extra-cellulare e un'acidificazione interna delle cellule [Lozupone et al., 2015 ]. Questi risultati, partiti da una semplice osservazione al microscopio, hanno portato all'individuazione di un nuovo bersaglio per future terapie: si tratta di un ulteriore e importante tassello verso un approccio non convenzionale nella ricerca sui tumori.
La scienza ha bisogno di occhiali per miopi?
ll cannibalismo tumorale è stato considerato per più di un secolo un fenomeno curioso e per molti versi negletto: solo recentemente è stato incluso in una lista di fenomeni generalmente caratterizzati dalla presenza di una cellula all'interno di un'altra cellula (appunto i celi-in-celi phenomena) e per molti aspetti comunque distinguibili da processi considerati più fisiologici come la fagocitosi e l'autofagia (Fais et ai., 2018).
La scienza corrente continua ad adottare un approccio interamente molecolare ai tumori, come anche alla gran parte delle malattie conosciute. Quello che ho appena illustrato viene completamente trascurato dalla scienza corrente, a causa di una progettualità miope e totalmente indifferente a tutto quello che esce fuori dai binari del mainstream.
Bisogna tristemente constatare, per chi ha l'onestà di farlo, che tale approccio non sta conducendo a scoperte in grado di influire su cambiamenti memorabili nel progresso delle conoscenze e men che mai utili al miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici.
Cosa avrebbe detto Darwin dei Tumori?
.jpeg)
Per concludere, vorrei fare un'osservazione che può apparire fantasiosa, ma che di nuovo diventa la naturale conseguenza dei nostri studi.
Come ho spesso detto in un mio lavoro precedente (Fais e Palmisano, 2020), i tumori crescono in un ambiente acido. Questo fatto, unito alla scarsa ossigenazione e allo scarso apporto di sangue e nutrienti, crea un microambiente estremamente ostile per cellule che non se ne sanno difendere.
Basti pensare, come accennavo sopra, che una cellula normale a un pH acido muore. Ma questo ambiente crea le condizioni per un processo di selezione, determinata dall'ambiente stesso, che lascia vive cellule che noi abbiamo già nel nostro organismo (le cellule embrionali) le quali proliferano perché sono le più adatte a farlo.
Possiamo quindi concludere che i tumori si sviluppano secondo un principio di selezione darwiniano di sopravvivenza del più adatto e quindi che i tumori derivano da un processo adattivo e non di trasformazione maligna.
C'è chi ha scritto molto su questo aspetto (Lloyd et al., 2016; Ardageva et al., 2019; Gillies et al., 2018) e una visione del tutto italiana su questo tema (Mazzocca et izl., 2018) è stata recentemente proposta in un articolo scritto da Antonio Mazzucca per la rivista «Scienza e Conoscenza» (Mazzocca, 2019).
Qualcuno comincia a pensare che il tumore, proprio in virtù di questa selezione adattiva, sia un tentativo del nostro corpo di far nascere un gemello dentro di noi, che sembra scontato dire abbia perso in partenza, ma che poi sembra poter vincere la resistenza del gemello che lo contiene. E quanto ciò somiglia alla definizione di cannibalismo? Una cellula più grande che ne contiene una più piccola.
Ma l'aspetto più interessante di questa scoperta è la correlazione fra la malignità tumorale e una sorta di regressione verso una vita più semplice (ancestrale), simile a quella delle amebe. Certamente ciò fa pensare che questa forma ancestrale sia già contenuta nel nostro corpo, e che quindi i tumori non sono delle formazioni aliene che si paventa vengano da un altro pianeta. Nascono da cellule che noi già abbiamo nel nostro corpo e che sono molto probabilmente le nostre cellule embrionali.
Non dimentichiamo mai che il nostro organismo si forma a partire da una iniziale lotta per la sopravvivenza. Le cellule che vincono vanno poi incontro a un progressivo processo di differenziazione che porta alla formazione degli organi e degli apparati che ci fanno vivere in questo mondo meraviglioso. Ma quelle cellule non scompaiono, rimangono dentro di noi.
La buona notizia è che il nostro corpo ha tutte le risorse per tenere sotto controllo quelle cellule e farle tornare nei loro nascondigli.
Ma di più, per arrivare a questo bisogna trattare il microambiente tumorale che le seleziona e noi abbiamo tutti gli strumenti per farlo.