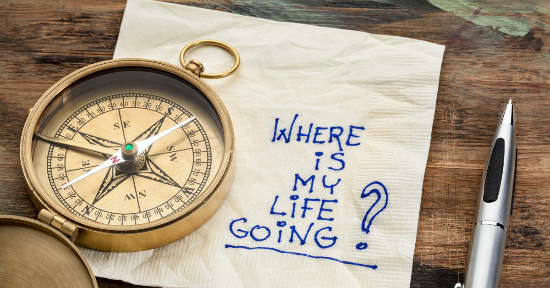Erica Francesca Poli ci aiuta a capire come elaborare un lutto
Pubblicato
2 anni fa
Ecco come attraversare il dolore, concederci il tempo, vivere il mistero
Viviamo in un’era che rifugge la morte, il dolore, il lutto, la perdita. Quando perdiamo una persona cara spesso ci viene detto di farci forza, coraggio, di guardare avanti, perché chi abbiamo perso non avrebbe voluto vederci tristi o infelici. Eppure è proprio nell’attraversamento di quel dolore che la morte può diventare un passaggio di trasformazione e arricchimento per ognuno di noi: ne abbiamo parlato con la dottoressa Erica Francesca Poli, psichiatra e psicoterapeuta.
Cosa ci accade quando perdiamo una persona cara?
Quando perdiamo una persona cara, perdiamo l’investimento emotivo – inconscio più ancora che conscio – che abbiamo messo in quella relazione. Quello che perdiamo è, a tutti gli effetti, una parte di noi, un pezzetto della nostra vita con quella persona, un pezzetto di quella identità che noi avevamo proiettato all’interno di quel rapporto.
Il vissuto della perdita è un vissuto che, necessariamente, ci investe pienamente nel nostro “essere quelli che siamo” e non poter più essere “quelli che siamo stati” in funzione di quel rapporto che – come tutto nella vita – si è anche costruito.
L’elaborazione del lutto riguarda proprio la possibilità di ritirare, di riportare a noi quello che avevamo posto al di fuori di noi in quel rapporto, ed è un percorso molto doloroso. La relazione con l’altro è l’unica relazione che ci permette di percepirci: l’altro come specchio, a questo punto, viene meno. Così come viene meno anche il contatto con l’altro, il tocco, l’aspetto più sensibile della relazione, che è il più profondo, perché tocca l’inconscio. Abbiano quindi il sentimento di tipo psichico e abbiamo lo specchio che è nel contatto con l’altro, il percepirci attraverso l’altro. L’elaborazione del lutto è un lavoro profondissimo.
Quanto tempo ci vuole per elaborare un lutto. O meglio, c’è un tempo “sano”, e un tempo che, invece, a un certo punto, diventa patologico?
La medicina, la psichiatria, necessariamente deve parlare di ciò che è “iatros” di ciò che è medicina della psiche, quindi anche di ciò che è malattia della psiche; deve quindi sancire dei termini. Noi sappiamo che il Manuale Statistico Diagnostico delle Malattie Mentali stabilisce un tempo di lutto fisiologico, che può variare da un anno fino anche a due anni. In quel periodo è possibile anche una sintomatologia depressiva, che appare depressiva ma che è fisiologica, naturalmente entro i limiti che la medicina stabilisce. La depressione, in questo caso, rappresenta un entrare dentro noi, il riportare all’interno qualche cosa che invece era stato estroflesso. Abbiamo una parentesi anche lunga, nella quale noi siamo fisiologicamente tristi, di una tristezza collegata alla perdita.
Oltre questo limite, iniziamo invece a parlare di lutto patologico. Queste, però, sono etichette, sono semplificazioni necessarie, che dobbiamo fare se vogliamo comunicare tra ricercatori, medici e scienziati. Poi è chiaro che l’individualità va ben oltre questo. Come clinica, come psicoterapeuta, ti rispondo che forse questa etichetta va bene per orientarsi, però ti dico anche che ho seguito tante persone arrivate in terapia con dei lutti non elaborati dopo anni. Se parliamo in termini di medicina narrativa ti dico che forse ogni persona ha il diritto al suo personale tempo del lutto.
Come individui che viviamo in questa società, facciamo più fatica rispetto al passato a elaborare e ad attraversare il tempo del lutto?
Assolutamente! Senza dubbio facciamo più fatica per delle ragioni che, come dici tu, sono proprio della società, sono di tipo collettivo.
Questa è una società che tende a tagliare fuori la morte. Il culmine di tutto ciò l’abbiamo visto in questi ultimi due anni in cui, per ragioni di emergenza – opinabili o meno, non entro nel merito di questo – abbiamo completamente scotomizzato il valore antropologico del rito della sepoltura e del funerale, che invece, sia a livello psichico che a livello collettivo, sancisce un fondamentale passaggio nell’elaborazione del lutto. Il rito lavora nella mente profonda, il rito lavora nell’inconscio, l’atto diventa un atto che è anche “psicomagico”, direbbe Jodorowsky.
Nei due anni di pandemia abbiamo dimenticato il valore riparativo e rielaborativo della sepoltura, un rito che appartiene profondamente al codice dell’umano.
Noi oggi sappiamo che già l’uomo di Neanderthal aveva elaborato tre pratiche fondamentali: cantava, ballava e seppelliva i morti.
Evidentemente il rito della sepoltura è insito in noi e ci definisce come specie.
La sepoltura è un rito di passaggio fondamentale nel lutto, rito che in passato veniva scandito da passaggi molto precisi e codificati. C’erano le veglie. C’era la veglia funebre, che aveva un senso a livello esoterico, per chi ci credesse, quello di lasciare l’anima ancora in quella intercapedine, prima di passare alla dimensione successiva. Ma anche per chi non credesse, aveva un valore antropologico, quello di permettere l’arrivo di tutti per dare un saluto: si trattava di un cuscinetto tra la vita e la morte. Quando poi veniva chiusa la bara, c’era un rito che doveva rendere omaggio, una ricapitolazione. Poi, la sepoltura. Dopo di che c’era un tempo del lutto, in cui ci si vestiva di nero, in cui c’era una serie di pratiche da seguire. Gli antichi greci, ad esempio, usavano il lacrimatoio, un’ampolla in materiale pregiato in cui venivano raccolte le lacrime di chi piangeva il defunto: quando le lacrime erano asciutte, quando il lacrimatoio si era asciugato, terminava un altro passaggio.
L’individuo nel passato era accompagnato da tutta una serie di rituali nel processo di elaborazione del lutto. Non dico che fosse tutto perfetto, ma questo era un elemento importante che noi abbiamo perduto. L’altro elemento che noi abbiamo perduto è proprio il rapporto con la morte. Noi siamo figli di un San Francesco, siamo in Italia e la religione cattolica in qualche modo l’abbiamo nel tessuto collettivo. È proprio San Francesco a parlarci di “sorella morte”. Invece no: per noi la morte è un qualcosa che bisogna allontanare sempre di più, quando in realtà, come dicono tutti i filosofi (ad esempio Heidegger), noi siamo per la morte, noi moriamo un pochino tutti i giorni. Se vogliamo cambiare, dobbiamo morire, come ci insegnano le stagioni. Ecco, tutto ciò questa società non lo considera, lo dimentica. Questo è molto dannoso per il nostro equilibrio interiore. Noi non sappiamo più morire a noi stessi, quindi, di conseguenza, non sappiamo neanche più rinnovarci.
Come facciamo, in pratica, ad attraversare il lutto?
Il lutto prima di tutto va vissuto. Il lutto è un’esperienza, che questa esistenza, questa dimensione incarnata, propone a ciascuno di noi. Bisognerebbe intendere il tutto in questo senso, cioè: è arrivato un tempo nella mia vita, nel quale io sono chiamato a entrare dentro di me, a contemplare qualche cosa, a farmi certe domande sul mistero, sul grande mistero al quale tutti ritorneremo, perché, per quanto possiamo prendere mille integratori, oppure stare attaccati a un generatore di ossigeno pur di non morire, prima o poi moriremo. Quando arriva il lutto nella tua vita, non dovresti cercare di eliminarlo, ma dovresti – anche con l’aiuto di chi può sostenerti in questo percorso – entrare in quella notte scura, perché lì c’è qualcosa di misterioso da incontrare. Questo dovrebbe essere l’intento anche del terapeuta.
A questo proposito ricorderò sempre una mia paziente, una donna con un certo spessore interiore, alla quale era morto il figlio sul colpo in un incidente in moto. Venne da me e mi disse: «Mi aiuti ad entrare in questa cosa. Mi aiuti a dire sì alla vita che mi ha dato questa cosa, perché se me l’ha portata adesso ci sarà una ragione e io devo trovarla, anche se non so neanche se sopravvivrò a questa cosa, tanto è lacerante il dolore. Io, però, non vengo da lei perché me lo tolga, ma perché lei mi sostenga in questo passaggio scuro della mia vita».
Questo dovrebbe essere l’intento, ma, affinché questo sia, medici, terapeuti, psicologi, insegnanti ed educatori dovrebbero essere preparati a questo, dovrebbero essere formati.
Hai citato anche gli educatori, per cui ti chiedo come spiegare il lutto ai bambini, come accompagnarli attraverso il lutto. È giusto ad esempio portarli a un funerale?
I bambini sono molto meno ingenui, molto meno “stupidi” — se così si può dire — di quanto noi grandi pensiamo. I bambini, soprattutto in età prescolare, quindi i bambini fino ai sei anni, sono ancora vicini alla sorgente, proprio perché tutta la loro struttura, anche psichica, non ha ancora abbracciato completamente il pensiero di tipo razionale. Loro sono ancora immanenti, in una dimensione molto più vicina all’anima. Sono molto più dentro quel flusso che noi poi, da grandi, ricerchiamo con la meditazione, con la preghiera, con tutte le pratiche spirituali. Contemporaneamente, i bambini sono corporei, terribilmente corporei in tutto ciò che vivono: loro si relazionano con il mondo e con le cose attraverso il sentire e il corpo, in realtà, è l’elemento spirituale ad essere predominante in loro. La vera spiritualità, infatti, passa dal sentire, non passa da una distinzione fra corpo e mente.
Dovremmo approcciare i piccoli sapendo che la loro saggezza avrà bisogno di essere sostenuta, elaborata, educata, cresciuta, che avrà bisogno di acquisire elementi per vivere in questa dimensione, ma che è comunque strettamente connessa alla sorgente. Pertanto, il bimbo, in realtà, conosce bene il mistero, molto meglio di noi, lo respira, ne è ancora intriso.
Ai bambini, anche piccoli, bisognerebbe quindi parlare della morte in questi termini, cioè come un qualcosa di molto misterioso, che ci interroga tutti quanti e che fa parte di quelle cose che, nella nostra esistenza, ci fanno sorgere tante domande e anche tanta curiosità. Il bambino tante volte si dimostra perfino più profondo dell’adulto. È quindi l’adulto a dover regolare il campo emotivo del bambino. Il bambino non ha paura del cadavere, è l’adulto ad avere paura che il bambino abbia paura del cadavere, quindi gliela trasmette. I bambini sono molto aperti a parlare della morte. Con mia figlia, ad esempio, io ne parlo; ha perso recentemente un nonno, ne abbiamo parlato e le ho chiesto: «Vogliamo dire qualcosa al nonno che è partito?». Le ho detto che il nonno ha lasciato questa dimensione per andare da un’altra parte e le ho chiesto: «Che cosa gli diciamo?». Lei ha alzato gli occhi al cielo, c’era la luna piena e mi ha detto: «Mamma, io direi questo: “Nonno, buon viaggio! Guarda, vai verso la luna che ti parla”».
Un bambino capisce perfettamente una dimensione altra, una dimensione che trascende, ma perché ne è completamente intriso.
La scelta di portare il bambino al funerale credo che debba essere ponderata da caso a caso, per età e per situazioni di famiglia. Il funerale, per il bambino, può essere un rito importante. Io, ad esempio, fui portata al funerale della mia amatissima bisnonna a cinque anni e mezzo e lo ricordo come un fatto importantissimo. Tutte le domeniche mio nonno mi portava al cimitero e mi raccontava le storie di famiglia: era un legame, una radice. Ma questo deve essere fatto nel momento in cui la famiglia, il genitore, abbia quella competenza emotiva di essere lui o lei o loro a essere a proprio agio. È sempre il campo che fa la differenza nella pedagogia. Il bambino è aperto, è pronto, a meno che non abbia particolari problematiche, che allora vanno tenute in considerazione.
In senso lato, ritengo che vada bene farlo con un contesto capace e abile nel regolare le emozioni del bambino, dandogli l’unico ingrediente di cui ha veramente bisogno: la presenza di cuore, la presenza emotiva. Se io, invece, sono in qualche modo a disagio, sono in angoscia o in difficoltà, allora anche il bambino non starà bene, perché egli necessita di un campo sicuro attorno a sé. Se non sono in grado di costruirgli un campo sicuro, allora forse è meglio che non lo porti al funerale. Se invece io sono a mio agio, in pace, pur nel dolore, allora posso portarlo, anzi sarà un insegnamento.