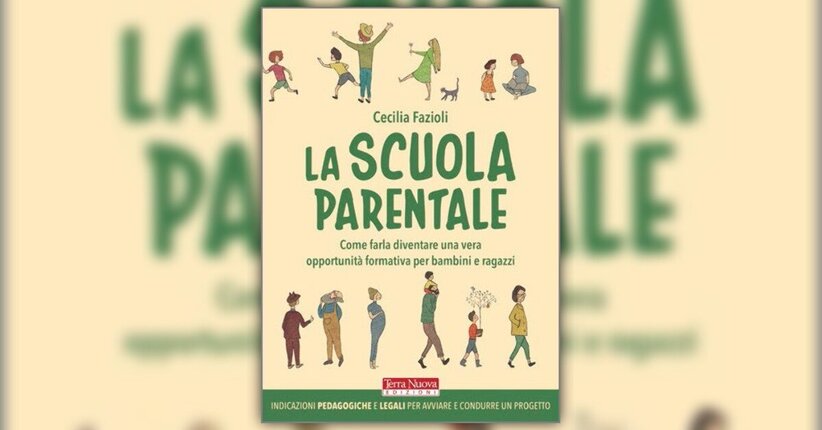Educarsi ed educare al dubbio
Pubblicato
5 anni fa
Leggi un estratto da "La Scuola Parentale" di Cecilia Fazioli e scopri quale straordinaria opportunità formativa rappresenti per bambini e ragazzi
Il bisogno intimo degli esseri umani è quello di desiderare certezze, quindi non è così insolito che chi educa e istruisce si ritrovi a scegliere di trasmettere certezze e risposte piuttosto che dare valore alla domanda, mentre invece occorre dotare il bambino e poi il ragazzo di bussole perché apprenda a orientarsi e perché sia capace di un pensiero autonomo.
La ricerca della certezza si sposa con la ricerca a tutti i costi del risultato, la riprova sono le cosiddette competenze, ovvero quando i ragazzi vengono valutati e certificati.
Siamo circondati da numerosi esempi che chiamiamo a volte metodi, a volte tecniche e altre ancora approcci o modelli e che attraggono l'attenzione perché spianano la strada, sventolano verità e rendono apparentemente più semplice realizzare una scuola parentale; ma in alcuni casi accade che la semplicità si traduce in semplificazione.
Dall'osservazione e dalla conoscenza di realtà che sono andate costituendosi in questi ultimi anni, ho spesso notato scelte basate sull'applicazione di un modello perché conosciuto da uno degli educatori. Poi, sulla scia di questo approccio, veniva sviluppata l'organizzazione di attività che di per sé hanno un potenziale formativo ma che, applicate senza un nesso con il contesto, diventano solo un bel passatempo.
Nascono inoltre progetti che si definiscono a partire dalle attività che in esso si svolgono; un esempio sono le scuole nate attorno alla pratiche dello yoga o pratiche spirituali, alla danza o a fare il pane, e coltivare l'orto e l'elenco potrebbe continuare.
A mio avviso siamo ben lontani da un'intenzionalità educativa che invece occorre mettere in campo, in quanto viene confuso lo strumento con il fine e si perde un passaggio fondamentale che è l'osservazione del bambino, traccia dalla quale dare forma a prassi rivolte al singolo, ovvero individualizzate.
Una scelta educativa non si può basare solo su cosa sanno fare gli adulti accompagnatori; il rischio è di creare contesti che sono un frullato di eventi e attività che si susseguono senza senso e connessione educativa, né tanto meno didattica.
Il saper fare dell'adulto si colloca nel bisogno di certezze, nell'essere un modello, ma la figura adulta può essere modello solo quando è vera. Un educatore imperfetto perché porta con sé dubbi è capace di riconoscere i propri limiti, è un adulto che impara assieme al bambino, con uno sguardo attento e rispettoso, vigile e presente.
Occuparsi di educazione significa allenare e applicare costantemente lo sguardo sulla complessità dell'ambiente, che accoglie bambini e bambine e che si evidenzia nell'agire quotidiano.
Ma l'evidenza è per coloro che vogliono vedere, che hanno il desiderio e la capacità di mettersi in gioco a favore di un incontro autentico.
Chi è presente con i bambini, chiamiamolo accompagnatore, educatore o maestro, deve essere in grado di preparare il contesto educativo dove si svolgeranno le esperienze del singolo bambino, fra i bambini e fra bambini e adulti.
Una teoria pedagogica si basa prima di tutto su studi, ricerche attorno all'essere umano e sviscera gli aspetti legati all'apprendimento. La teoria e il suo ideatore sono legati al contesto storico in cui è stata sviluppata e quindi deve essere conosciuta approfonditamente.
Pensare a un determinato modello, o a più modelli teorici, e applicarlo deve presupporre che sia chiara quale idea di bambino, ancora più esattamente di uomo, perseguire all'interno della scuola parentale.
Scegliere di adottare un approccio unico oppure integrato presuppone che le prassi che ne conseguono (organizzazione, atmosfere ambientali, strumenti didattici, oggetto educativo, modalità, tempi e finalità) siano applicate conoscendo quale sviluppo di bambino si persegue.
L'applicazione di mere strumentazioni o i kit per l'educazione avulsi dalla teoria rischiano di essere sconnessi, incoerenti e non legati ai bisogni della comunità. Sicuramente danno sicurezza all'educatore che necessita di comprovare la sua verità, ma possono danneggiare l'intero processo di apprendimento.
Questo non vuole dire che l'intenzionalità dell'educatore non deve basarsi su creatività e valutazioni personali, ma le scelte è importante che appoggino su significati educativi profondi e autentici per riconoscere e rispettare la libertà di ogni bambino di fare esperienza.
Il dubbio ha a che fare con l'errore, la cui etimologia deriva da errare, cioè vagare, deviare, sbagliare. Tramite l'errore possiamo avere l'occasione di acquisire consapevolezza e nutrirci di meraviglia per l'inaspettato.
Porsi nella posizione del dubbio crea spazio per uno sguardo che sa individuare l'errore non per giudicarlo, ma per scoprire strade alternative o per riprendere la retta via.
Queste posture sospese, perché alla ricerca di qualcosa, alimentano l'azione e una prassi che può divenire sempre più consapevole perché attenta, con la volontà di creare condizioni di ben-essere per tutti.