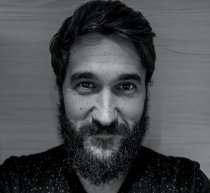È possibile evitare il medico?
Pubblicato
2 anni fa
L’autodeterminazione della salute non dipende dai titoli accademici, ma dalla capacità di saper ascoltare il proprio corpo e scegliere persone che sanno accompagnare lungo il percorso della guarigione
Esistono alternative al medico? No. Il medico non è sostituibile, eppure è evitabile. L’autodeterminazione in termini di salute è il primo passo per guarire il rapporto medico-paziente, per sciogliere il legame di profonda dipendenza reciproca su cui si fonda la sanità moderna. L’accurata ri-definizione dei ruoli dell’iter terapeutico e la revisione del potere dei titoli del medesimo iter sono l’orizzonte comune a cui ambire come specie.
Ri-definire i ruoli
Istituire dei ruoli sanitari sulla base di un percorso formativo universitario, benché teorico e pratico, non può rappresentare in alcun modo un traguardo della modernità.
Se per sviluppare le arti sono serviti millenni di storia dell’umanità basati sul trapasso di nozioni ed esperienze da un maestro, più o meno “socialmente riconosciuto”, ad un allievo selezionato sulla base di innumerevoli attitudini, l’assenza di reali maestri e reali discepoli in ambito sanitario ha trasformato la “guarigione” in un concorso a premi: chi più occulta il sintomo è insignito di titoli sempre maggiori.
Il frutto di decenni di sanità costruita esclusivamente su esami teorici e prove pratiche è il crescente divario tra figure di talento e figure da apprendimento, tra professionisti dotati di qualità essenziali alla cura e professionisti capaci di apprendere il contenuto dei testi indicati per un esame.
Il problema è che la salute e la guarigione di un essere umano non sono fenomeni da laboratorio, non sono parametri che stanno comodamente in una tabella su di un libro e per le quali sono sufficienti competenze intellettuali. La conoscenza teorica e pratica della materia medica può coprire solo una parte delle capacità necessarie a chi accompagna salute e malattia.
In assenza di attitudini emotive e psichiche volte alla comprensione e all’interpretazione profonda di segni e sintomi e in mancanza di un ascolto vigile su più livelli della condizione del paziente è sterile gestione del quadro clinico l’esercizio di una professionalità sanitaria.
La ri-definizione dei ruoli è la sfida che oggi dobbiamo intraprendere come popolo, dai livelli squisitamente antropologici fino a quelli aziendali: chi può ricoprire un ruolo? Quali attitudini sono necessarie al suo svolgimento? Ma soprattutto, quale ruolo?
I ruoli oggi in utilizzo nella relazione terapeutica sono:
- il “guaritore”: colui che conosce i rimedi e le tappe da percorrere, che deve raggiungere l’inquadramento generale del paziente e che esercita su di esso il suo potere terapeutico;
- il paziente: portatore di una disfunzione o sofferenza, colui che deve attendere che il guaritore compia l’opera per cui lo paga, e che deve adempiere a continui atti di fiducia e abnegazione per perorare la causa.
Una visione viziata e deviata dei ruoli come quella contemporanea non può muoversi verso nuovi paradigmi di salute perché carente sin dalle sue basi logiche; urge l’inserimento dell’unico ruolo definito secondo natura, l’unico che permane oltre le trasformazioni culturali dei popoli: il corpo.
Il corpo è colui che svolge la guarigione in quanto tale, è colui che conosce la strada per infiammare e per lenire, che sa dosare ormoni stimolanti e inibitori, che conosce la storia esatta del paziente e che impiega il meglio delle sue potenzialità genetiche, chimiche, fisiche ed energetiche per evolvere il quadro clinico.
Restituito il ruolo del protagonista al corpo possiamo ridefinire i due ruoli paritari e secondari: il paziente diventa l’interprete del proprio corpo, colui che ha la responsabilità completa della raccolta ordinata dei dati, che conosce il proprio limite e i propri punti forti, che ha individuato le zone d’ombra fisiche emotive e relazionali, che ha la disciplina per sostenere pratiche terapeutiche e la saggezza per sospenderle quando divengono superflue.
Il “guaritore” finalmente esautorato dei suoi poteri sacerdotali e profetici può così tornare un “compagno di salute”, colui che ha collezionato migliaia di storie e che può quindi accompagnare quella del paziente, che possiede i giusti consigli e le nobili arti necessarie a perseguirli, che sa prevedere i segni del corpo e che può formare e accompagnare il paziente per il tratto di strada necessaria all’evoluzione del quadro clinico.
È in questa prospettiva che il guaritore divenuto compagno di salute si fa paziente tanto quanto il paziente, è qui che attesa e osservazione divengono i binari comuni su cui giocare i talenti del primo e la disciplina del secondo, dove la contemplazione del corpo si fa metodo e lo spazio terapeutico si distende fino ai confini del pensiero dei due.
Revisione del potere dei titoli
Il possesso di una laurea sanitaria o di un corso professionalizzante è sufficiente per esercitare un ruolo sia nella sanità pubblica che in quella privata. A chi abbiamo dato il potere di conferire titoli? Chi ha la responsabilità di associare una persona a un titolo abilitante? L’università? Gli ordini?
Nel 2013 l’8° classificato nel ranking mondiale dei ricercatori scientifici della riabilitazione, quello con il maggior numero di pubblicazioni in peer reviewed pubblicate a proprio nome in Italia, era il presidente di uno dei corsi di laurea più prestigiosi della nazione.
Non solo egli non praticava le discipline fisioterapiche da quasi 20 anni, ma avendo selezionato uno specifico ambito accademico di specializzazione aveva sacrificato tutte le competenze trasversali del mestiere per aumentare il numero di pubblicazioni iper-specialistiche.
L’intera commissione di docenti da lui guidata, ricca di ricercatori e ricercatrici a lui molto affini, aveva il compito di conferire il titolo di fisioterapista, il titolo abilitante alla pratica.
Basterebbero queste poche immagini per comprendere come l’ambito accademico universitario, votato allo studio e alla sperimentazione nel migliore dei casi, abbia perso gradualmente ogni credibilità nel conferimento di titoli abilitanti.
Perché un titolo possa avere una valenza per il paziente, cioè per colui che riceverà le cure di un terapeuta, non dovrebbe essere coinvolta almeno in parte la comunità dei pazienti?
Se da una parte serve che un ente dedicato alla formazione riconosca la preparazione di uno studente, dall’altra serve che gli utilizzatori finali di tale formazione possano validare tale percorso. Non è realmente spendibile una competenza teorica e pratica se il paziente non vi può intessere una relazione terapeutica, se non si può beneficiare di tali competenze. Allo stesso modo un “guaritore” acclamato dalle folle, ma ostile al dibattito scientifico e in nulla affine ai traguardi della ricerca è tendenzialmente foriero di pratiche e intuizioni pericolose, spesso rapidamente individuate come inutili e controproducenti dai pazienti stessi. Perché un titolo possa essere abilitante serve un complesso processo umano e non uno esclusivamente accademico o popolare.
Conclusione
Dato un individuo capace di autodeterminarsi in termini di salute, cosciente del proprio e dell’altrui ruolo, il posto di “compagno di salute” può essere occupato da un naturopata al pari di un medico, da un farmacista o un erborista al pari di un osteopata o un logopedista, compatibilmente con la fase che si desidera affrontare.
Migliore è il lavoro svolto dal paziente su di sé, e perciò dal corpo a riposo, minore sarà la responsabilità del compagno di salute e migliore sarà la relazione dei 3 attori.
Un buon traguardo per la nostra specie sarà la realizzazione di una vera e propria rete di guariti e guaritori, di un sistema di salutogenesi distribuito per cui ogni punto giochi la propria parte nella partita di salute dell’umanità, chi con un titolo, chi con la propria storia, ma ciascuno con un ruolo.

Le caratteristiche essenziali di un compagno di salute
Se hai iniziato un percorso di autodeterminazione di salute e hai lavorato sui ruoli (per non cercare in un operatore olistico o sanitario quello che cercavi in un medico), e sui titoli (non ti basta una semplice laurea per fare visita ad uno specialista) ecco le caratteristiche essenziali da cercare in un compagno di salute:
- Che goda di buona salute e abbia raggiunto per sé stesso i punti che desideri imparare.
- Che possieda le competenze teoriche necessarie all’inquadramento della tua individualità.
- Che intrattenga relazioni scambievoli e virtuose con i terapeuti delle discipline che non padroneggia.
- Che riconosca il proprio compito di compagno e non abusi del proprio potere terapeutico.
- Che sia erede di una scuola o un lignaggio terapeutico che ha fatto proprio con esperienza intuizione e dedizione.