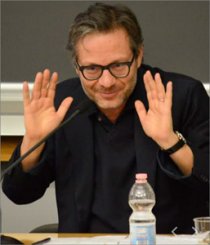Come affrontare una perdita?
Pubblicato
2 anni fa
Quale lavoro è necessario compiere per ritornare a vivere? Per farci nuovamente desiderare di vivere? E, ancora, cosa accade invece quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto?
Al centro di questo tema c'è il rapporto della vita umana con l'esperienza della perdita.
Cosa accade dentro di noi quando la malattia e la morte strappano dalle nostre braccia persone che davano senso alla nostra vita e al nostro mondo?
Quando siamo costretti a perdere chi abbiamo tanto amato? Ma anche quando gli ideali per i quali abbiamo vissuto si infrangono irreversibilmente, o quando dobbiamo lasciare una terra o una casa che avevano accolto la nostra vita e alle quali eravamo profondamente legati?
Scopriamolo insieme leggendo un estratto dal libro:
Il trauma della perdita
Si ripete più volte nella nostra esistenza perché la vita non può che scorrere attraverso i suoi innumerevoli morti. Non solo quelli che sono effettivamente defunti, ma tutte le morti - tutte le perdite - che abbiamo simbolicamente vissuto.
Quale vuoto si è spalancato dentro e fuori di noi appesantendo la nostra vita sino al punto - come può capitare nelle circostanze più drammatiche - da sospingerci a rifiutare la vita?
E quale lavoro è necessario compiere per ritornare a vivere? Per farci nuovamente desiderare di vivere? E, ancora, cosa accade invece quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto?

- Un lutto può cronicizzarsi (melanconia)
- Può essere apparentemente negato (mania)
- Può dare luogo a un vero e proficuo lavoro simbolico intorno al vuoto apertosi con la perdita dell'oggetto (lavoro del lutto).
Nessun lavoro del lutto può mai compiersi pienamente.
Esiste sempre un resto, qualcosa di indimenticabile, che non ci consente di staccarci del tutto dalle nostre perdite. In questa chiave la nostalgia intrattiene un rapporto particolare con quel resto indimenticabile che il lavoro del lutto non è in grado di assorbire.
Nostalgia: rimpianto o gratitudine?
È il punto in comune tra nostalgia e lutto: il carattere irreversibile della perdita si associa alla necessità di recuperare quello che abbiamo perduto. Tuttavia nessuno può ritornare dalla morte, così come nessuno può ritornare al tempo mitico dove la nostra nostalgia vorrebbe riportarci. Né il lavoro del lutto né il sentimento della nostalgia possono infatti recuperare quello che abbiamo perso per sempre.
Ma la nostalgia può avere due diversi volti: il primo è quello del rimpianto, il secondo è quello della gratitudine.
Nostalgia-rimpianto
La nostalgia-rimpianto assume le forme della rimemorazione di un passato felice ma irrimediabilmente perduto, sebbene costantemente agognato.
Questa nostalgia segnala il protrarsi del dolore del lutto per ciò che abbiamo perso e non ci sarà mai restituito: la madre, l'infanzia, il vigore della giovinezza, le occasioni, gli amori, una vita diversa, i progetti ecc.
È la condizione di base di ogni lutto: la presenza dell'oggetto perduto è ancora avvertita tra noi, negli spazi che abbiamo condiviso, nel tempo che abbiamo vissuto insieme, sopravvive nelle cose che gli erano appartenute nella memoria e nei nostri ricordi.
Eppure lei, non è più qui, non posso vederla, toccarla, abbracciarla, parlarle, ascoltarla, sentirne il profumo. Un'interruzione senza possibilità di recupero ha scavato un fossato insuperabile tra noi e tra il nostro passato e il nostro presente.

Nostalgia-gratitudine
La seconda forma della nostalgia è quella della nostalgia-gratitudine, che non resta imprigionata nel rimpianto, ma diviene una potente risorsa psichica di rinnovamento della vita. Mentre la prima forma della nostalgia è animata da una profonda volontà di ritorno a quello che essa vagheggia come un "paradiso perduto", la nostalgia-gratitudine ritrova proprio in certi dettagli indelebili del nostro passato la forza per agire con più vitalità nel presente e per progettarsi generativamente nell'avvenire.
È la forma essenziale che può assumere il compito dell'ereditare. Non si tratta qui di aspirare al ritorno - non c'è nessun ritorno possibile all'origine, alla madre, all'infanzia, alla patria ecc. - perché il nostro viaggio nell'esistenza, come ripeteva Sartre, è un viaggio con un biglietto di sola andata.
Noi tutti siamo viaggiatori senza possibilità di ritorno, senza possibilità di ripercorrere all'indietro il nostro viaggio nella vita perché dietro di noi non c'è più nulla se non i nostri innumerevoli morti.
Il luogo del ritorno è, dunque, in se stesso un luogo impossibile, una vera e propria assenza, perché non c'è mai nessun luogo al quale poter ritornare.
Ma è, appunto, sullo sfondo di questa impossibilità del ritorno che diviene possibile compiere il nostro viaggio di sola andata.
In questo caso non siamo più noi a essere aspirati melanconicamente dal nostro passato ma è il nostro passato che ci visita in modo sorprendente offrendoci ogni volta la possibilità di ripartire.
Non siamo fatti per morire
Non siamo fatti per morire, ma per nascere, affermava Hannah Arendt.
Tuttavia la nostra vita inizia a morire già con il suo primo respiro. Non solo perché la morte è il destino inesorabile che ci attende alla fine della vita, ma perché in ogni istante della nostra vita c'è qualcosa che si perde, si stacca, si separa da noi stessi, scompare.
In questo senso la morte non è, come ricordava Heidegger, l'ultima nota della melodia dell'esistenza che ne chiude il movimento, ma una "imminenza sovrastante" che ci accompagna da sempre. Questa imminenza sovrastante della morte definisce propriamente la forma umana della vita.
L'esistenza di un fiore o di un animale vive senza conoscerla.
Il fiore e l'animale sono, infatti, espressioni di una vita eterna. Anch'essi sono destinati a perire, ma la loro vita non conosce l'assillo e il pensiero della morte. La vita animale è vita sempre piena di vita, vita che non conosce la ferita della finitezza o, meglio, che non conosce la finitezza come ferita necessariamente mortale della vita.

L'uccello nel cielo, come il giglio nei campi, per riprendere una nota immagine evangelica, non conoscono l'erosione del tempo perché vivono in un eterno presente, in un solo grande "oggi". Essi hanno deposto ogni forma di attesa, non restano sotto il peso incombente della fine perché il loro beato magistero ha sospeso il divenire del tempo in un "adesso" che non si lascia corrompere dal divenire delle cose.
La trappola nel lavoro del lutto
Nel lavoro del lutto la trappola immaginaria dell'idealizzazione e della de-idealizzazione viene evitata perché al centro c'è il riconoscimento pieno del valore dell'oggetto perduto, del suo carattere imperdibile e del suo significato essenziale per la vita del soggetto.
Questo riconoscimento incrementa inevitabilmente il dolore della perdita anziché attenuarlo, come invece accade, paradossalmente, sia nella melanconia (l'oggetto è ancora presente sebbene nella forma dell'assenza) sia nella mania (l'oggetto perduto non ha nessuna importanza).
Il lavoro del lutto è un lavoro simbolico attorno alla perdita reale dell'oggetto che non lascia che il soggetto sprofondi nell'abisso della nostalgia melanconica, né che si erga maniacalmente contro l'oggetto sostituendolo rapidamente con un'altro oggetto.
Si tratta invece di un lungo e atroce lavoro psichico. Una vera e propria convalescenza durante la quale le forze vitali, fiaccate dall'esperienza dolorosa della perdita, vengono lentamente recuperate e rinnovate.
Ne troviamo una straordinaria descrizione in Nietzsche, nella Prefazione a La gaia scienza, laddove il filosofo tedesco assimila l'esperienza del lutto a un inverno severo che assidera la vita e, di contrasto, il lavoro del lutto ha un "tempo di aprile", ha un vento "australe" che venendo da sud scioglie la vita stessa dal gelo che l'ha avvolta.
Qui la convalescenza viene descritta come uno stato di "ebbrezza" perché coincide con la fine dell'inverno e la possibile ripresa della vita punto è necessario che la libido ritorni a investire se stessa su nuovi oggetti, che abbandoni, come direbbe Freud, la sua fissazione melanconica sull'oggetto perduto, che ritorni in possesso del soggetto in modo che egli la possa reinvestire su nuovi oggetti.
Il coraggio del funambolo
In un'altra potente immagine Nietzsche sottolinea il carattere atroce e necessario del lavoro del lutto. Mi riferisco a quella del funambolo presente nei primi capitoli di Così parlò Zarathustra che vive la sua vita nel continuo pericolo di cadere. Zarathustra-Nietzsche osserva con ammirazione la sua maestria di spiegarsi sulla corda tesa nel vuoto.

Questa immagine simboleggia il tentativo dell'uomo di rinunciare alla protezione della religione e della vita moralmente ammaestrata del gregge per esporsi al grande abisso di una vita libera.
Nel coraggio del funambolo Zarathustra-Nietzsche vede, in altre parole, un'anticipazione del suo tentativo di oltrepassare la versione metafisica dell'uomo, di condurre l'uomo al di là di se stesso, verso l'Ubermensch (l'oltreuomo). Non a caso Zarathustra, nel suo racconto, si presenta lui stesso nei panni di una di un danzatore sopra una corda attesa sull'abisso.
Affinché sia possibile una nuova forma di vita per l'umano - affinché sia possibile realizzare un processo di soggettivazione o, come direbbe Jung, di individuazione -, è necessario fare esperienza non solo della morte del vecchio uomo - o dell'"ultimo uomo" -, dell'uomo che rigetta "la fedeltà alla terra", che non vuole rinunciare alla morale e alla religione come scudi di fronte al rischio dell'esistenza, ma anche del proprio stesso lutto per questa perdita.
È necessario perdere anche le proprie identificazioni, il proprio Io, la propria identità.
Non a caso è l'apparizione di un pagliaccio che fa venire meno l'equilibrio precario dell'acrobata facendolo schiantare al suolo.
Nella letteratura junghiana si tratta di un'incarnazione dell'Ombra. Ma una volta caduto a terra e privo di vita, Zarathustra decide di portare il corpo dell'acrobata sulle proprie spalle. Egli sa che il rischio di dire "Sì!" alla vita non può escludere la presenza incombente della morte.
L'irruzione del pagliaccio incarna la presenza dell'imprevedibile, dell'ingovernabilità, dell'eccesso che non può mai essere scongiurata.
Il funambolo che precipita e dunque il simbolo dell'impossibilità di vivere appieno l'esistenza senza contemplare il rischio del fallimento e dello smarrimento.
"Precipitò in basso, in un mulinello di braccia e di gambe": il destino dell'acrobata è in irremediabilmente segnato e assomiglia a quello che in diverse occasioni tutti noi abbiamo sperimentato.
Zarathustra si inginocchia davanti al suo corpo sfracellato in un gesto di profonda intimità offrendosi di seppellirlo con le proprie mani. Non abbandona il cadavere, ma, come accade anche all'Antigone di Sofocle nei confronti del fratello morto in battaglia, resta presso il morto. Nietzsche-Zarathustra s'incarica del difficile lavoro che precede, accompagna e solitamente segue ogni sepoltura.
Se per un verso la sua parola predica "la fedeltà alla terra" al di là di ogni possibile facile consolazione -il grande "Sì!" all'esistenza -, per un'altro verso egli è consapevole della necessità del lavoro del lutto, conosce il rigore terribile dell'inverno. Per questo rimane al fianco del cadavere dell'acrobata per poi portarne il peso sulle proprie spalle.
Il cammino di Zarathustra nel buio della foresta e della notte, con il cadavere del funambolo sulle spalle, è una potente immagine del lavoro del lutto. Non accade forse sempre così? Non portiamo sulle nostre spalle chi abbiamo amato ed è caduto? Non è questa un'immagine dell'esistenza come costituita dall'inizio alla fine dai suoi innumerevoli morti?
Dobbiamo allora immaginarci Nietzsche-Zarathustra con il peso della morte addosso impegnato in un difficile lavoro del lutto.

Mentre la folla che assisteva allo spettacolo del funambolo si disperde rapidamente allontanandosi dal luogo della tragedia, Zarathustra sa che il lavoro del lutto è un lavoro che esige una prossimità al morto. È un lavoro solitario che non può essere fatto da una massa. Egli conosce bene la pena necessaria che esso comporta.
Ma se si vuole riattivare la vita si deve sempre dare sepoltura simbolica alle ombre del nostro passato. Non per cancellarle dalla nostra esistenza, ma per incorporare la loro esistenza nella nostra senza che questo processo generi un'idealizzazione melanconica.
Continua a leggere il libro di Massimo Recalcati: