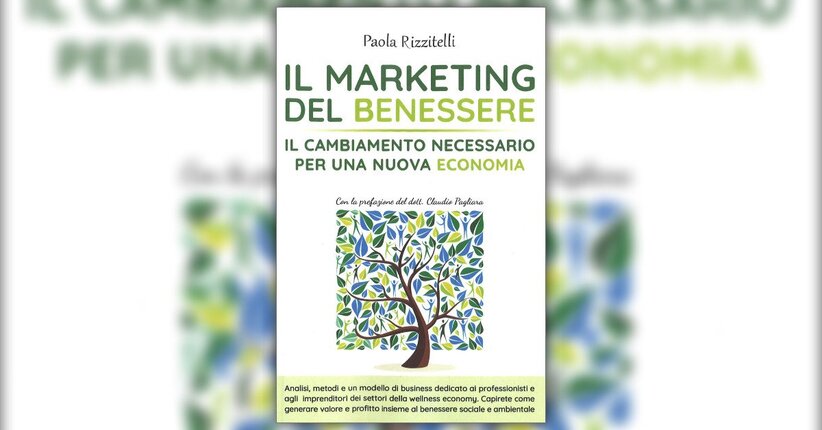Che cos'è la ricchezza, e che relazione ha con la felicità?
Pubblicato
5 anni fa
Leggi un estratto da "Il Marketing del Benessere" di Paola Rizzitelli e approfondisci il cambiamento necessario per una nuova economia
Amartya Sen si domanda: "Può il tenore di vita di una persona essere alto se la vita che conduce è una vita di privazioni?".
Per lui la ricchezza non è certamente il bene ultimo che cerchiamo, ma la perseguiamo solo in vista di qualcos'altro. Il desiderio di ricchezza non è fine a se stesso ma alla condizione di libertà di poter raggiungere e condurre il tipo di vita che desideriamo e apprezziamo.
In verità, per numerosi anni l'economia del benessere è stata dominata dalla concezione dell'utilitarismo.
L'utilitarismo è una scuola di pensiero economico e filosofico-morale. Si sviluppa all'inizio del XIX secolo con Jeremy Bentham.
Le persone, nel pensiero di Bentham, considerano solo l'interesse individuale, non quello sociale o della classe di appartenenza, cercano la realizzazione dei loro desideri. Ne consegue che tutti i fenomeni economici hanno come fattore determinante il comportamento umano.
La scuola utilitarista pone l'individuo al centro dell'analisi economica. Secondo gli utilitaristi ogni fenomeno economico deriva dalla tendenza di ogni persona a massimizzare la propria utilità individuale. Teoria che si è affermata in modo ufficiale per lungo tempo e che ha portato gli stessi economisti a sovrapporre il concetto di felicità individuale a quello di utilità individuale.
La considerazione del benessere sociale come la risultante della somma delle utilità individuali è anche detta welfarismo.
Quindi la vera ricchezza si sposta dal possedere determinate quantità di denaro alla realizzazione dei propri obiettivi individuali.
Ma come possono utilità individuali se pur sommate fra loro stabilire cosa sia la felicità e guidare le politiche economiche?
Peraltro, come rileva Sen, la tendenza dell'essere umano all'adattamento potrebbe portare persone che vivono in una condizione di privazione a non cercare il cambiamento e ad adattare a quella condizione i propri desideri ed aspettative.
La tesi utilitarista è stata di fatto criticata e allontanata dalla riflessione economica poiché non esistono strumenti scientifici per quantificarla e perché non è possibile paragonare la felicità delle persone.
Un'altra argomentazione interessante che merita di essere conosciuta è quella sostenuta prevalentemente da Kaheman, Riis e altri contemporanei che agli inizi del secolo mettono in rilievo la dualità delle prospettive dell'individuo il quale, nel vivere un'esperienza, potrà riferire del benessere sperimentato e del benessere valutato. Questo perché in realtà successivamente all'esperienza è il ricordo che ne abbiamo a condizionare la nostra valutazione.
La vita di un individuo pertanto andrebbe considerata come una successione di momenti che tuttavia spariscono rapidamente.
Quando chiediamo a qualcuno com'è andata una certa esperienza (viaggio, concerto, cerimonia etc.) ci risponde in realtà il sé che ricorda e valuta grazie alle memorie, che sono tutto ciò che conserviamo delle esperienze.
Kahneman, rileva che possono verificarsi errori cognitivi nella misurazione della felicità soggettiva, e scrive: "si pensi ad un amante di musica classica che ascolta ad alto volume una lunga sinfonia, al termine di essa, a causa di un graffio sull'estremità del disco, viene prodotto un fastidioso e forte rumore. Un incidente di tal genere e spesso descritto dall'affermazione di come la conclusione difettosa abbia rovinato l'intera esperienza. Di fatto, non è l'intera esperienza ad essere rovinata, ma solo la memoria di essa. L'esperienza dell'ascolto della sinfonia è quasi interamente perfetta e il finale, seppur danneggiato dal difetto del disco, non ha inficiato la qualità di ciò che e stato ascoltato nella precedente mezz'ora" (Kahneman in Bruni, Porta).
Questo rileva anche un altro fenomeno importante, chiamato "Regola del picco/finale" secondo cui la valutazione degli episodi sia frutto dei sentimenti legati a momenti rappresentativi dell'evento come quello finale, ovvero la media fra quello finale e altri momenti, a prescindere dalla durata dell'evento stesso.
Quale parte di noi dovrebbe guidare le strategie? Pare che maggior interesse abbia suscitato quella che ricorda, rispetto a quella che vive l'esperienza.
Di fatto la storia dell'aggregazione umana ci ricorda che i movimenti e i tumulti sociali si sollevano proprio quando le persone insoddisfatte concordano sulle cause della loro insoddisfazione, valutando le esperienze vissute e cercano un accordo su cosa fare in merito. Questo dimostra la prevalenza del ricordo e della percezione.
Comprenderete quindi la difficoltà sia di operare scelte amministrative ed economiche che soddisfino efficacemente il benessere collettivo, sia quella di misurare in termini economici la felicità, considerando le implicazioni emotive soprattutto emergenti nel momento finale.