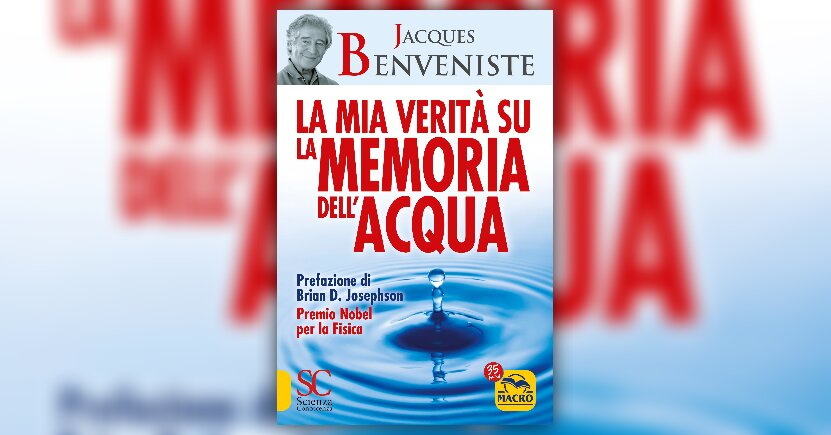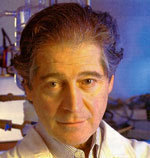Censura scientifica
Pubblicato
3 anni fa
Leggi un estratto del libro La Mia Verità sulla Memoria dell'Acqua di Jacques Benveniste
Nel 1989, mi ritrovo pertanto completamente solo, ma ben determinato a proseguire le mie ricerche sulle alte diluizioni.
Sono ben radicato nell'ostinazione di voler dimostrare la riproducibilità degli esperimenti (tuttavia già acquisita), consapevole di rischiare l'esilio scientifico, grazie all'impegno profuso di gente che, surrettiziamente, usa tutte le proprie energie per prosciugare le fonti economiche che sostengono la mia attività.
A partire da questo periodo, in effetti, i finanziamenti per il funzionamento dell'U 200 stanziati dall'Inserm cominciano, come per incanto, a diminuire.
Progressivamente, i contratti sottoscritti dalla mia Unità con le società farmaceutiche, che rappresentano risorse paragonabili per importanza ai crediti pubblici, non vengono rinnovati. E questo nonostante la maggior parte delle ricerche riguardi la terapia dell'infiammazione e dell'allergia in dosi classiche e non le alte diluizioni.
Un incidente mi conferma l'ostracismo di cui sono vittima: un alto funzionario di una delle più importanti società farmaceutiche francesi mi propone di tenere presso la sua stessa società una conferenza di presentazione dei miei lavori sulle alte diluizioni.
Lo averto che l'organizzazione di tale riunione certamente si rivelerà impossibile per lui. Il funzionario non condivide le mie preoccupazioni e protesta elogiando la libertà di parola che regna nella sua società.
Alcune settimane dopo, mi spiegherà per lettera che sta combattendo «come il diavolo nell'acquasanta» per ottenere che io possa tenere la conferenza e parlare delle mie ricerche. L'invito non mi perverrà mai.
Il "processo" che mi viene intentato (senza avvocato e senza alcun rispetto dei diritti dell'imputato) mi appare ancora più ingiusto dell'esigenza di riproducibilità, alla quale mi sono piegato, alquanto prematura in questa fase delle mie ricerche. Perlomeno nei termini riduttivi in cui viene posta. In effetti mi trovo in una fase di elaborazione in cui si procede per tentativi; fase che necessita della correzione di alcuni errori.
Nella storia delle scienze, nessun programma di ricerca che comporta un minimo di innovazione ha funzionato e ha prodotto risultati riproducibili al primo colpo. L'essenza stessa della ricerca contempla la possibilità degli errori e l'inseguimento febbricitante del dettaglio che non quadra può condurre a un vicolo cieco e far si che ciò che è stato osservato ieri non sia facilmente riproducibile oggi.
Un esempio..ci sono voluti venticinque anni per riprodurre l'esperimento iniziale di Otto Loewi sulla trasmissione chimica degli impulsi nervosi a livello delle membrane sinaptiche, uno dei progressi più inaspettati e più fecondi della fisiologia moderna.
Oggi, il cosiddetto fenomeno della memoria dell'acqua "funziona", è cioè riproducibile, tutti i giorni nel mio laboratorio, con una tecnica talmente semplice, da essere su Internet a disposizione di tutti.
Nel 1989 nonostante gli affronti e gli abbandoni, malgrado i colleghi che mi evitano o che non mi salutano più, io continuo a riprodurre i miei esperimenti di degranulazione dei basofili ad alta diluizione, cercando in tutti i modi di trovare una falla, un errore, l'esistenza di una procedura operativa che possa spiegare l'inspiegabile. Tengo conto delle critiche che mi sono state rivolte da Nature sui presunti errori di campionatura.
Faccio selezionare i campioni di sangue affinché contengano un numero sufficiente di basofili e preciso ormai in tutti i rapporti sugli esperimenti destinati alla pubblicazione che per gli esperimenti sulle alte diluizioni utilizziamo solo i campioni di globuli bianchi basofili che reagiscono a dosi classiche di anticorpi.
Nel corso del 1989, quando ormai la mia posizione a capo dell'Unità 200 è in pericolo, Alfred Spira, uno dei migliori specialisti francesi di statistica applicata alla biologia e direttore dell'Unità 292 dell'Inserm, accorre in mio aiuto.
Spira ed io non abbiamo un'amicizia personale, ma ci conosciamo ormai da una ventina d'anni. Avevamo lavorato insieme alcuni anni prima presso il consiglio scientifico dell'Istituto.
Alcuni giorni dopo la pubblicazione di un articolo su Le Monde in cui si parlava delle difficoltà incontrate dal mio gruppo di ricerca, Spira intervenendo in una "tribuna libera" sullo stesso giornale afferma: «Quando un ricercatore pone delle domande che mettono in discussione conoscenze accertate, non fa altro che il suo lavoro, nient'altro che il suo lavoro. Volergli impedire di proseguire le ricerche, dal momento che non è stato dimostrato che si sbaglia, è una limitazione insostenibile alla sua libertà, alla nostra libertà».